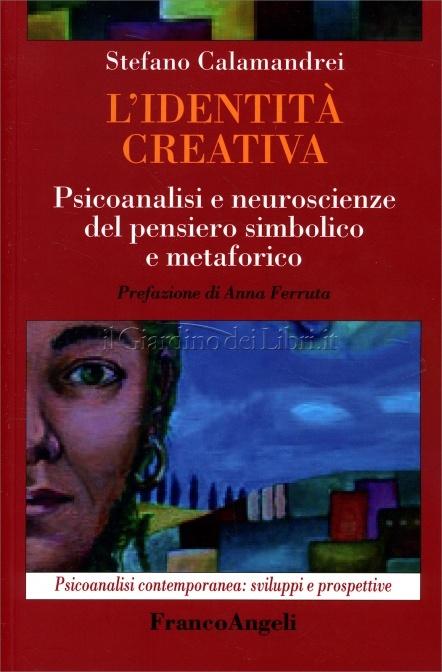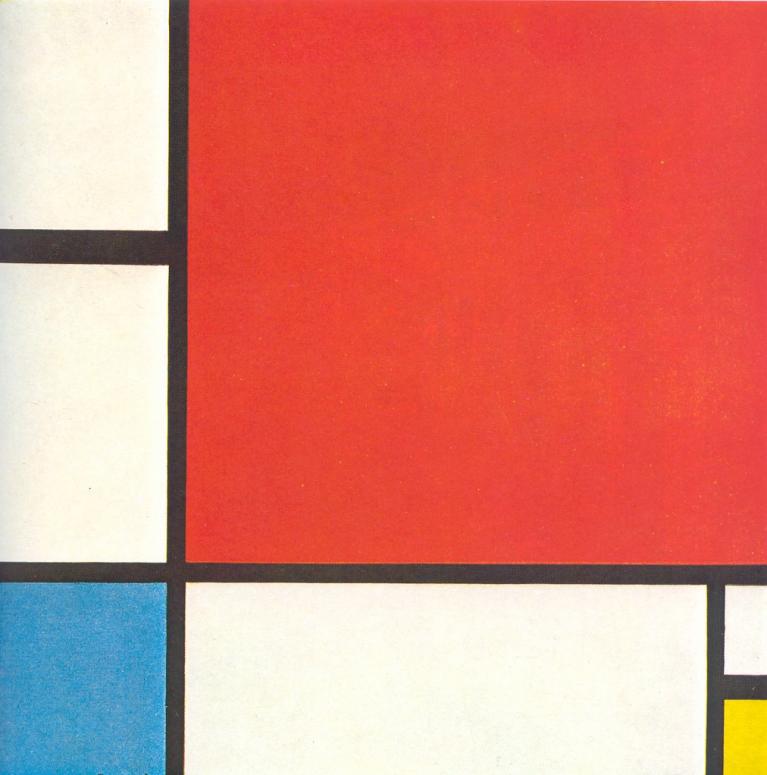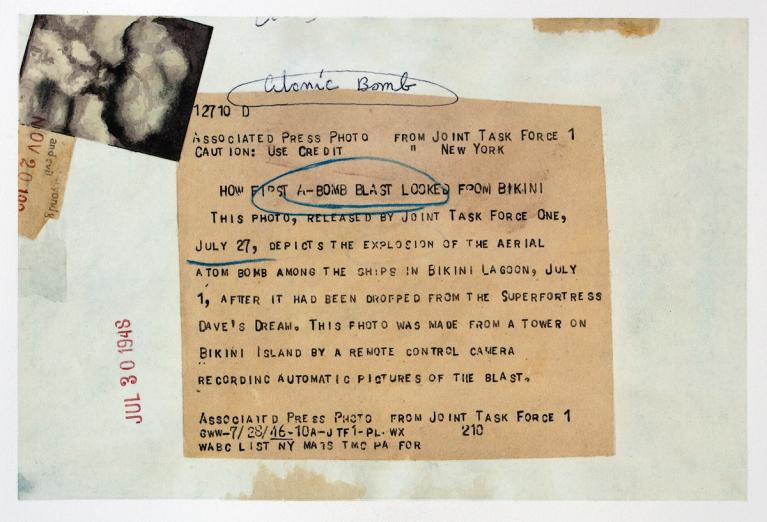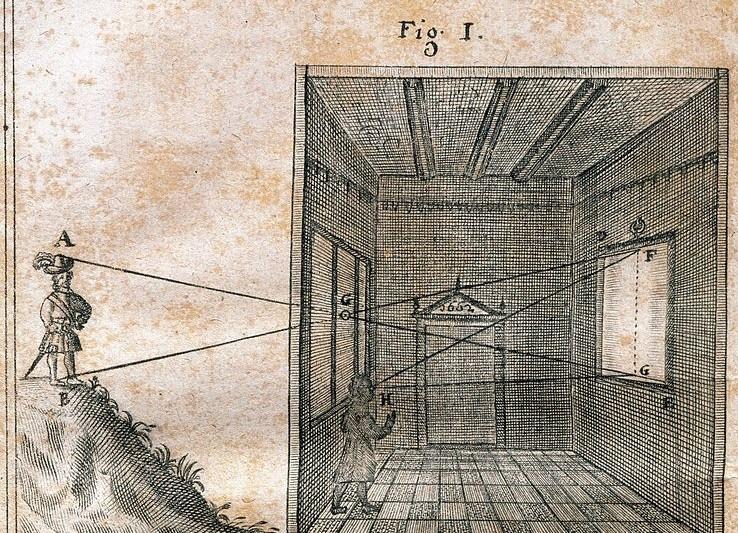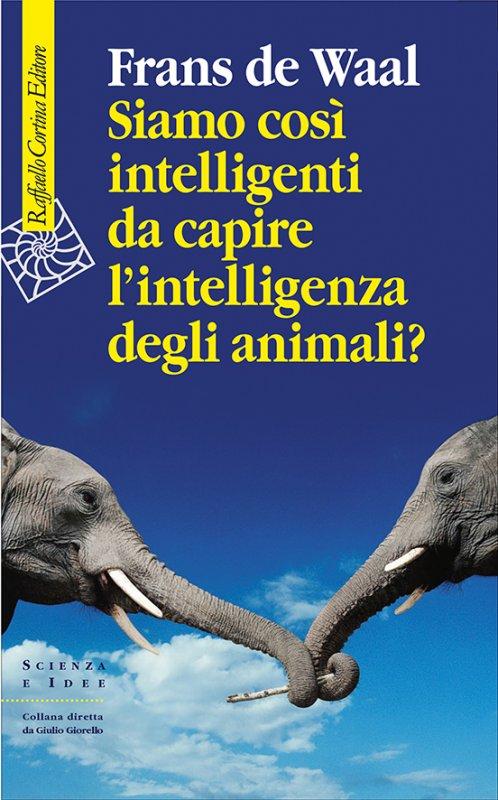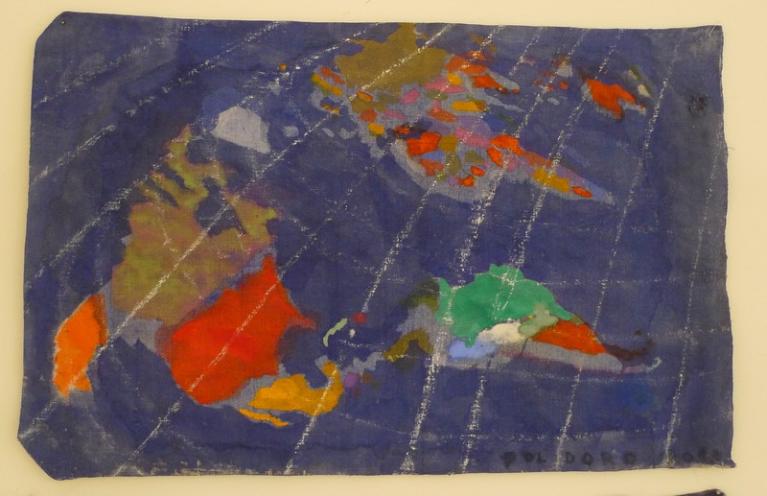Il rapporto tra rappresentazione dal vivo e immagini riprodotte, la pedagogia, il remake. Sembrano queste le linee guida della recente edizione di Vie Festival, un’invenzione di Emilia Romagna Teatro. È difficile sempre in un festival che non dichiari un indirizzo tematico individuare fili rossi. Eppure in quest’ultima rassegna internazionale di autunno firmata dal direttore uscente Pietro Valenti, tra molti spettacoli presentati, quelle tre tracce sembrano balzare evidenti, con alcune intersezioni particolarmente interessanti, con un evidente rilievo affidato al tema della trasmissione (della didattica, della pedagogia), strategico oggi nel nostro sistema teatrale (e politico e sociale) smemorato, alla deriva. Per questo lo conservo per ultimo, affrontando per primo quello del remake, denunciando subito di non aver visto tutti i numerosissimi spettacoli in cartellone tra Modena, Bologna, Vignola e Carpi.
Remake: CollettivO CIneticO e Motus
Prendi un balletto ottocentesco, La sylphide di Maria Taglioni, 1832, e viralo (o anche solo citalo, magari insieme al suo primo remake di Fokine del 1909) in una sfilata di moda postpunk o postnerd, intrisa di umori fantasy e manga. Sylphidarium. Maria Taglioni on the Ground di CollettivO CineticO rievoca le origini della danza romantica, l’atto di affermazione del tutù e dei passi sulle punte. Francesca Pennini non solamente riapre i conti della danza contemporanea con l’avo balletto classico, come stanno facendo anche altri coreografi, per esempio Alain Platel in Nicht Schlafen: nella leggerezza sognante romantica, in una storia di amore e morte piena di esseri immaginosi, immette ginnastica, acrobatica, culturismo, peso fisico, deriva immaginativa mediatica, in un affettuoso smontaggio ironico del canovaccio ottocentesco. Introduce l’elemento di terra nello slancio aereo, mostrando la natura di freaks degli esseri magici dell’armamentario fantastico romantico. Il confronto con il diverso – interpretato attraverso corpi spesso bloccati nei loro slanci e con costumi da Conan il barbaro o da Trono di spade– salda le trasfigurazioni del passato e la freddezza matematica, algoritmica, richiesta per attraversare le seduzioni dei tempi presenti.
![Sylphidarium, ph Camilla Caselli.]() Sylphidarium, ph Camilla Caselli.
Sylphidarium, ph Camilla Caselli.
Un altro remake (autoremake, in questo caso) è quello di Splendid’s di Motus, poiché la compagnia ritorna al testo di Genet quattordici anni dopo la prima versione. Come in quella, con l’attuale Raffiche. Rafales>Machine (cunt) fire siamo in una camera d’hotel dove è asserragliato un gruppo armato di mitra che ha rapito un esponente del sistema. Nel 2002 erano uomini di una banda criminale; qui sono donne che combattono per affermare la libertà queer d’identità, ugualmente in un balletto della ribellione, della tensione erotica, del conflitto, del tradimento. Sullo spettacolo torneremo in altra occasione: qui ricordiamo solo che il testo non è più quello di Genet, ma una nuova pièce scritta da Magdalena Barile e da Luca Scarlini, perché l’agenzia che gestisce i diritti dell’autore francese ha vietato il cambiamento di genere dei personaggi, un assurdo per uno scrittore che ha fatto del travestitismo e della lotta per la libertà la sua bandiera estetica. Di quel lavoro del 2002 rimangono i balletti con i mitra come figura ritmica conduttrice e l’ambientazione, a stretto contatto di pubblico, in una suite di un grande albergo (per Vie era il Carlton di Bologna, dal 5 al 7 gennaio sarà il Grand Hotel di Rimini).
Splendid’s rivive diverso, così come molti altri lavori del passato di Motus vengono riproposti dal vivo o in installazioni video nella rassegna bolognese Hello Stranger, che osserva dal punto di vista del presente i venticinque anni di attività della compagnia. Quello che si è chiamato “nuovo teatro”, e anche la sua “terza ondata” degli anni ’90 alla quale i Motus appartengono, è quasi banale dirlo, ha ormai una tradizione che permette sguardi retrospettivi e dovrebbe indurre analisi in profondità di quello che è stato fatto, dei muri aperti o abbattuti e delle occasioni mancate. Raffiche, con questa trasposizione-reinenzione, permette di confermare l’idea che l’ensemble riminese ha lavorato quasi sempre su una icasticità virale da rivista di moda, individuando, per ogni stagione, un tema da declinare in forme e formati glamour, intercettando un qualche “spirito dei tempi” in una bidimensionalità priva di profondità che corre omologa alla società dell’assenza, della trasparenza, del vuoto, dell’estraneità (Hello Stranger).
![Raffiche motus, ph Endna.]() Raffiche motus, ph Endna.
Raffiche motus, ph Endna.
Così in Rooms c’erano stanze di motel e vite di passaggio, in Ics si agitava il tema della gioventù no-future della nuova Europa senza identità, nei contest della ribelle Antigone, nel lavoro con Judith Malina, nella Tempesta emergevano la crisi e la reazione militante di Occupy Wall Street e degli Indignados e ora – in modo forte e spigoloso in MDLSX, come in un disincantato, ironico musical in Splendid’s/Raffiche– viene esplorato il tema del queer e del gender. Con mezzi che superano il teatro nella relazione con l’immagine riprodotta, con la musica e con playlist spesso molto heavy, con il balletto come in Raffiche, con protesi varie che mettono in secondo piano l’abilità dell’attore (e proprio in Raffiche, dove le protesi a momenti non sono sufficienti e la distanza dal pubblico è ravvicinata, alcuni interpreti di fronte al testo risultano funzionare sottotono).
Video teatro, film live
E qui siamo già passati al secondo filo del festival, anche se per via trasversale, più attraverso Motus che grazie al loro spettacolo. In Vie 2016 moltissimi sono stati i lavori che si misuravano con il video in scena, con l’immagine riprodotta in diretta o in differita, con l’immagine in dialogo con la musica. Cito solo, a quest’ultimo proposito, il concerto dei C’Mon Tigre su figure di Gianluigi Toccafondo e Più Giù di Stefano Ricci, che disegnava dal vivo, raccontando, come nel suo ultimo libro edito da Quodlibet, la madre Loredana, accompagnato da Giacomo Piermatti al contrabasso e da Antonio “Rigo” Righetti al basso.
Lo spettacolo di apertura del festival, Tristesses di Anne-Cécile Vandalem, era un thriller ambientato in un’isoletta della Danimarca. La scena era costituita di casette colorate: ciò che avveniva negli interni, nelle stradine tra l’una e l’altra, nei punti oscuri e nascosti era mostrato in video sopra la scenografia. Si trattava di una storia segnata dal fallimento dei macelli dell’isola, dalla fuga della popolazione, da intrighi di banche. Dominava la vicenda l’incombere di uno di quei partiti ultranazionalisti che pullulano in Europa facendo leva sulle conseguenze della crisi. Uno spettacolo “politico”, che avrebbe avuto bisogno del genio grottesco di Mathaler per decollare, e che invece restava ancorato a semplificazione e tautologia, nonché a una tristezza opaca di paesaggio nordico o di certi film belgi.
![Tristesses, ph Cristophe Engels.]() Tristesses, ph Cristophe Engels.
Tristesses, ph Cristophe Engels.
Ben più trascinante era Kiss & Cry, un vecchio lavoro della danzatrice Michéle Anne de Mey, un curriculum che vanta presenze nella compagnia di Bejart e in Rosas di Anne Teresa de Keersameker, e di Jaco van Dormael, il regista di Toto le héros e di Dio esiste e vive a Bruxelles. Lo spettacolo avveniva tutto su schermi, per mani danzanti, per pupazzetti, stazioncine, treni giocattolo, avvolti nelle nebbie di amori svanenti, di brume o liquidi inghiottenti, di vite cui sfugge l’amore. Sul palco rumori prodotti dagli animatori e dai tecnici e un set avvolto nel buio, squarciato da lucine che si accendevano via via sui diversi soggetti, con varie telecamere che riprendevano le animazioni, creando una vicenda malinconica sullo svanire dell’amore, sul passare del tempo e il volar via della vita, in uno spettacolo seducente, coinvolgente.
Tutto in immagine si svolgeva Perhaps All TheDragons dei Berlin, ogni spettatore davanti a uno schermo in cui una persona, di varia nazionalità, raccontava una storia vera. Poi si veniva invitati, varie volte, a cambiare schermo, e così a poco a poco si creavano intrecci tra le varie vicende, rimandi e dialoghi da un video all’altro, a illustrare la legge dei sei gradi di separazione, viaggiando con ironia, in modo virtuale, tra diverse realtà, in queste intersezioni “aumentate”.
![Belarus free theatre phalex brenner.]() Belarus free theatre phalex brenner.
Belarus free theatre phalex brenner.
All’immagine documentaristica in scena non sapeva rinunciare Burning Doors, lo spettacolo di denuncia del bielorusso Balarus Free Theatre su repressione, incarcerazione , tortura di militanti e dissidenti nelle carceri dell’impero di Putin, un lavoro che non aggiungeva molto a quello che si conosce o la faceva a un livello superficiale, acquistando spessore solo grazie alle parole del solito Dostoevskij, insistendo sul lato emozionale più facile con corpi sbattuti, colpiti, incarcerati, tirati da corde, con colpi, sussurri e grida, giocando smaccatamente con il bisogno di adesione politica e di solidarietà del pubblico. Qualcosa di parecchio già visto dai tempi del Living e di Grotowski, mai più con l’intensità di Malina, Beck o Cieslak.
Così come finiva molto nel didattico con la ricostruzione di vari anni di lavoro con i ragazzi disadattati, prima figli di operai e altri emarginati delle periferie, poi migranti, The Misfits del Backa Theatre di Göteborg (Svezia). Un lavoro politico vecchio, un brechtismo di maniera, semplificatorio ancora una volta, che immaginiamo abbia un senso nelle situazioni di intervento, ma che a noi risulta solo, in modo esasperante, testimoniare la buona volontà di impegno sociale di chi lo svolge, con mezzi più agitatori e alleviatori di cattive coscienze che efficaci.
![Piugiu, Stefano Ricci prove, ph Acrolando Paolo Guerzoni.]() Piugiu, Stefano Ricci prove, ph Acrolando Paolo Guerzoni.
Piugiu, Stefano Ricci prove, ph Acrolando Paolo Guerzoni.
Trasmissione
Con la compagnia svedese, però, siamo sulla soglia del passaggio all’altro filone, quello della pedagogia, della trasmissione, perché si ripercorrono quarant’anni di attività mostrando anche il lavoro dei giovani inseriti nella compagnia. Terrò per ultimo il lavoro che di più secondo me attraversa le tracce individuate. Accennerò solo al fatto che il festival vive, ormai da anni, grazie a un’accorta politica di legami internazionali, in particolare con il progetto Prospero che coinvolge vari teatri del vecchio continente. Alcuni spettacoli vengono coprodotti, ridistribuendo così i costi e incrociando attori e registi di differenti nazionalità. Quest’anno erano presenti alcune scuole per attori nate all’interno del programma. Tra tutte ricordiamo, ancora, la scuola di alta formazione di Ert, quella che ha prodotto Santa Estasi di Antonio Latella, il mirabile spettacolo saga raccontato la settimana scorsa da Maddalena Giovannelli in questa rubrica, un viaggio nella tragedia greca, in alcune tragedie rese storie capaci di parlare ai nostri tempi con una lingua modernissima (sugli aspetti pedagogici del progetto si veda anche l’articolo di Renzo Francabandera su “Paneacqua culture”).
![Santa estasi elena, ph Brunella Giolivo.]() Santa estasi elena, ph Brunella Giolivo.
Santa estasi elena, ph Brunella Giolivo.
Antonio Latella ha formato un gruppo eccellente di giovani attori (speriamo che resti unito, che possa proseguire a rappresentare questa opera e possa cimentarsi con altre creazioni), accompagnati da un più ristretto gruppetto di giovani drammaturghi, sfidando entrambi, attori e drammaturghi, con il compito difficile di attraversare le origini del nostro teatro, la tragedia (anche questo un remake), interrogandola se ancora ha qualcosa da dire a corpi di giovani e a occhi e orecchie di spettatori dell’era liquida e virtuale. La scommessa è stata vinta, dimostrando anche come una scuola di teatro (in questo caso un corso di alto perfezionamento post diploma) debba essere legata a una pratica concreta, a compiti precisi di confronto con testi e situazioni sceniche, affrontati senza reverenze. È una strada con un bel respiro progettuale, in un momento in cui molti teatri si sono affrettati a creare, per rispondere ai requisiti della nuova legge, scuole con poca anima, che duplicano di fatto istituti già esistenti, in un settore in cui la disoccupazione, la sottoccupazione, la mancanza di orizzonti è la regola.
![Perhaps all the dragons, ph Marc Domage.]() Perhaps all the dragons, ph Marc Domage.
Perhaps all the dragons, ph Marc Domage.
Un altro passaggio pedagogico importante del festival è stato il dare palco a giovani compagnie e a drammaturghi alle prime o seconde prove, per permettere loro di confrontarsi spesso per vari giorni con un pubblico vero. Ricordiamo Allarmi! di Emanuele Aldrovandi, messo in scena da ErosAntEros, un lavoro riuscito a metà sui nascenti neonazismi. In certi passaggi risultava superficiale e prevedibile il testo, che pure riservava qualche bel colpo di scena e una buona dose d’ironia; eccessivamente stereotipata era la protagonista, che avrebbe forza drammatica se solo abbandonasse i troppo facili modelli, mentre gli altri attori riservavano prove divertenti, anche se con il rischio a volte della macchietta. Delicato e un po’ slabbrato era Deliro bizzarro di Carullo e Minasi, un viaggio in un Centro di salute mentale in cui i ruoli, a un certo punto, sembrano confondersi, ribaltarsi, invertirsi; efficace Scusate per il disagio degli Omini, prima tappa di un bel progetto sulla Porrettana, una linea ferroviaria minore, in decadenza, e sulla popolazione che la percorre e la popola ogni giorno.
Giorgio Morandi – Virgilio Sieni
Dove vari fili si uniscono è in Ballo 1890_Natura morta di Virgilio Sieni, a un primo sguardo una sfida guascone e impossibile, quella di attraversare i quadri di Giorgio Morandi con la danza di cento interpreti: un coro, la Corale Savani di Carpi, più una cinquantina di non professionisti, di corpi normali, di varie età, belli, con la pancia, bassi, grassi, anziani, giovani, prestanti o con qualche fragilità fisica. Questo lavoro, oltre a implicare la trasmissione e la diffusione della danza, in fondo è anche un tipo particolare di remake: Sieni, con la sua Accademia sull’arte del gesto, da anni parallelamente alle creazioni con i professionisti esplora le possibilità dell’arte coreutica in varie situazioni di massa o di gruppo dove agiscono corpi normali, indagati nelle loro componenti fisiologiche e archeologiche, nelle possibilità dello scheletro, nelle fessurazioni che con il movimento espressivo si possono aprire nelle posture quotidiane. I corpi sono potenziati e portati verso una forma di bellezza democratica mossa dal desiderio di costruire una nuova comunità in divenire. Ballo 1890 (la data di nascita di Morandi) diventa una tappa, una riproposizione, una variazione di un percorso che ha accumulato già vari, differenti episodi.
![Motus raffiche, ph Luca del Pia.]() Motus raffiche, ph Luca del Pia.
Motus raffiche, ph Luca del Pia.
L’immagine, come in altri spettacoli considerati di Vie, è anche qui elemento narrativo di riferimento, ambientazione, sfondo; a differenza degli altri però non compare in scena, ma rimane come un rimando e come un’assenza. Parlo delle figure apparentemente ferme delle tele di Morandi, le bottiglie, le ciotole e i poveri oggetti ripetuti in vari quadri dal pittore bolognese. Una serie, quella di Morandi, sempre variata, un continuo remake che apre ogni volta orizzonti imprevedibili, di composizione, di luce, di ombre, di proporzioni, proprio come nei lavori con i non professionisti di Sieni – che lui preferisce chiamare (a ragione) amatori o addirittura amatori emozionali –, creazioni in cui la grammatica e la sintassi della danza sono semplici, modulari, ma la tensione compositiva e espressiva diviene altissima.
Nello spettacolo siamo davanti a una massa che si muove su uno sfondo di suoni pulviscolari, con il muro compatto della Corale, ogni tanto riassorbito dai danzatori o pronto a incorporarli in sé. Una figura si trascina su gambe inerti, un’altra di una ragazza sottile e malferma rimane isolata, il gruppo rientra, riprende, incamera, svela un dondolare di due linee di danzatori seduti al centro che si tengono in reciproco equilibrio per le braccia, mentre la massa si chiude su di loro, poi si riapre, mette in evidenza un’anziana signora come dispersa, poi ancora l’uomo dalle gambe inerti, crea un gruppo a destra, a sinistra, poi assorbe la Corale, poi la Corale si sposta a destra, a sinistra, riemerge dalla massa, lasciando un gruppo di figure a terra che si distendono, e si rialzano, e tornano mucchio, in movimenti che si ripetono e riempiono lo spazio come il pulviscolo della luce che avvolge le opere di Morandi, i suoi oggetti, e che li staglia su quegli sfondi inerti.
![Ballo 1890 natura morta, ph Virgilio Sieni.]() Ballo 1890 natura morta, ph Sonia Maccari.
Ballo 1890 natura morta, ph Sonia Maccari.
Musica fatta di piccoli moduli, ugualmente ripetuti, di parole spezzate, vocalizzate, sbriciolate dal coro diretto da Giampaolo Violi, una figura carismatica e sognante, con i lunghi capelli bianchi che con gesto ampio e saltelli abbraccia gli occhi e le voci dei suoi cantanti che ripetono, spezzano parole poco decifrabili, simili a quelle di Arvo Pärt o di qualche altro compositore nordico, e scopriremo che sono termini, frasi in dialetto, carpigiano, per non dare allo spettatore facili appigli. La semplicità del dialetto smontata, evidenziata, reso metafisico pullulare, risplendere, come fa Morandi con le bottiglie, con le stoviglie.
Ed è un lavoro di trasmissione, di scoperta dei corpi, di ascolto: per cui per esempio vedrete aggirarsi una figura quasi immobile, semplicemente ritta, che non fa molto, ma che risalta dai controcanti degli altri ballerini. Scoperta di abilità, partendo dalle possibilità e dalle difficoltà motorie di ognuno. Tensione verso l’estremo, prestando attenzione alla verità dei corpi. Gruppi si formano e si disfano, in serie, e dalla tensione delle membra, delle figure, dalla composizione, penseresti alla pittura manierista: ma cosa c’entra il manierismo con Morandi? E invece la chiave è proprio quel ripetere, quel dare una forma artistica (là le ciotole e le bottiglie, qui i corpi, le voci e i loro movimenti in serie, con continui piccolissimi scarti) alla cosiddetta realtà, trasfigurare per elementi noti.
È un lavoro, quello di Sieni, come quello di Morandi, per ricordanze tonali, con soggetti che girano al minimo, con simboli necessari, vocaboli sufficienti a evitare le secche dell’astrattismo assoluto; sullo stesso pretesto egli ha potuto rendere timbri sentimentali diversi e sempre diversamente inclinare la sua severa elegia luminosa, in un impegno d’interiorità spoglia. Quello che avete appena letto è un montaggio di frasi che Roberto Longhi usa per raccontare, a suo modo, la pittura di Giorgio Morandi, in uno scritto del 1945. Parole che si adattano benissimo al meraviglioso tentativo (riuscitissimo) di Sieni di danzare le nature morte del “monaco” di via Fondazza, che “nella sua cella è dunque il contrario dell’esteta nella sua torre d’avorio” (Longhi, ancora). Una danza che si riscopre nella sua tendenza a un’umanissima ascetica astrazione, una semplificazione che diventa complessità, pronta a narrare l’umile magnificenza del corpo e degli incontri che permette; una danza che si trasmette, che diventa comunità accompagnata dal suono muro, dal suono culla, dal suono viaggio fisico e interiore della Corale Savani. Per finire, tutti insieme, ballerini e coristi, con le mani alzate, nella luce corpuscolare, crepuscolare, come in un atto di resa, come in un supplizio, o come piuttosto in un abbraccio di accoglienza della luce stessa, del respiro, del ritmo, del mondo.