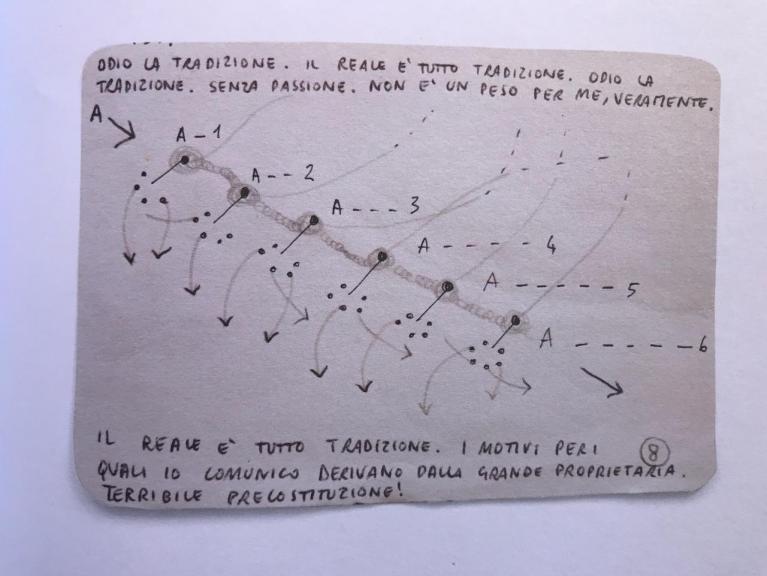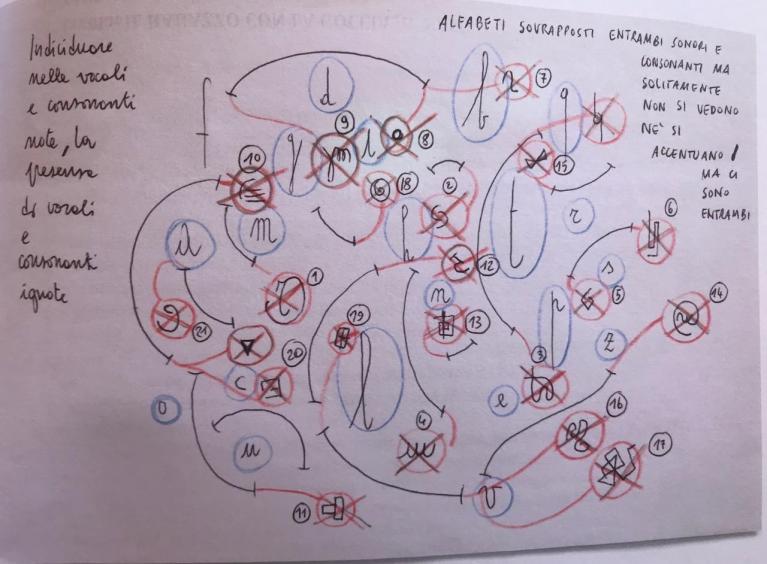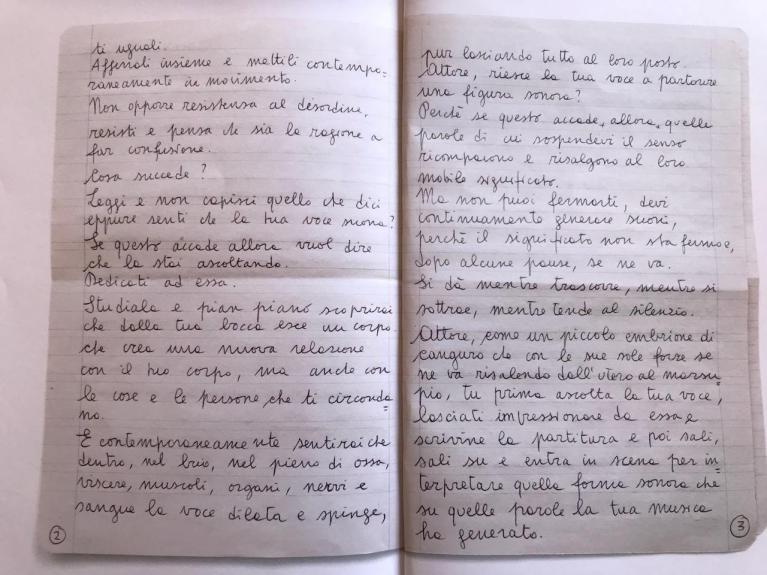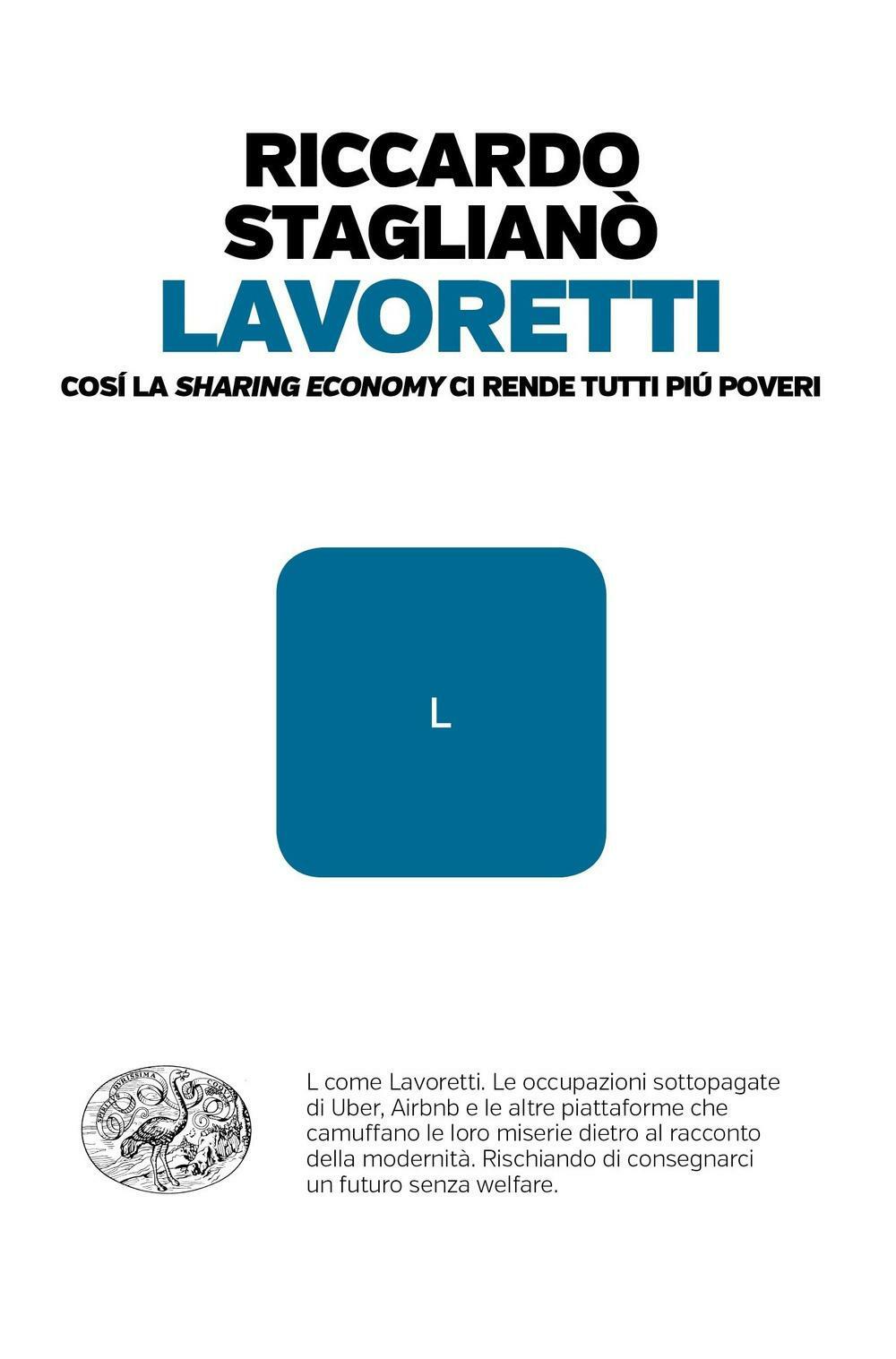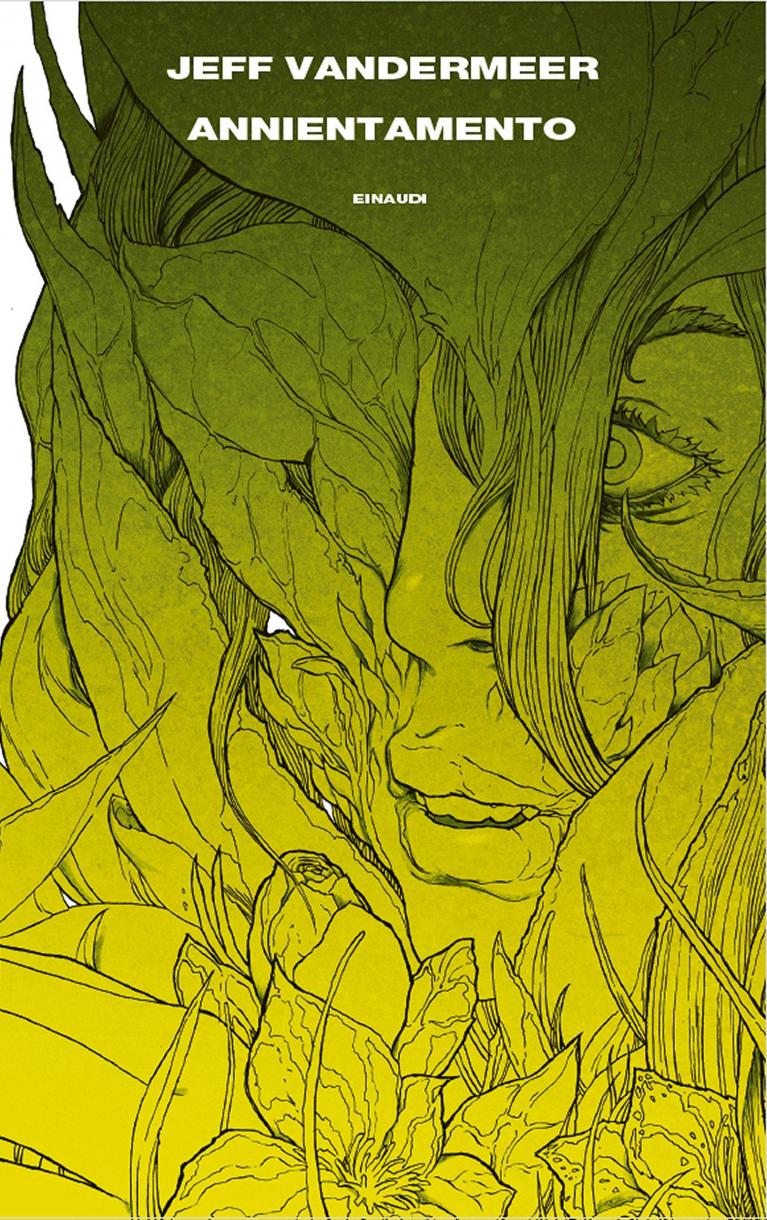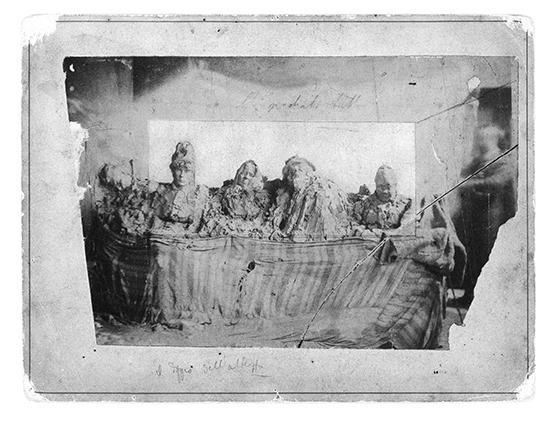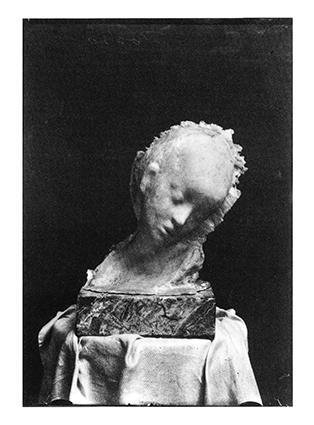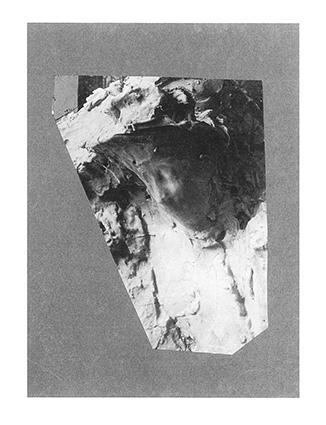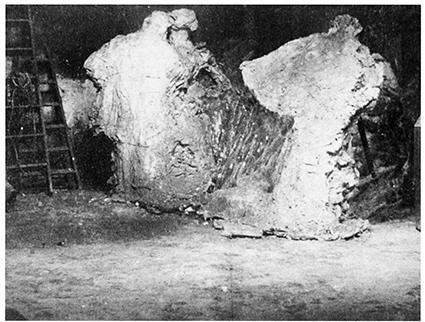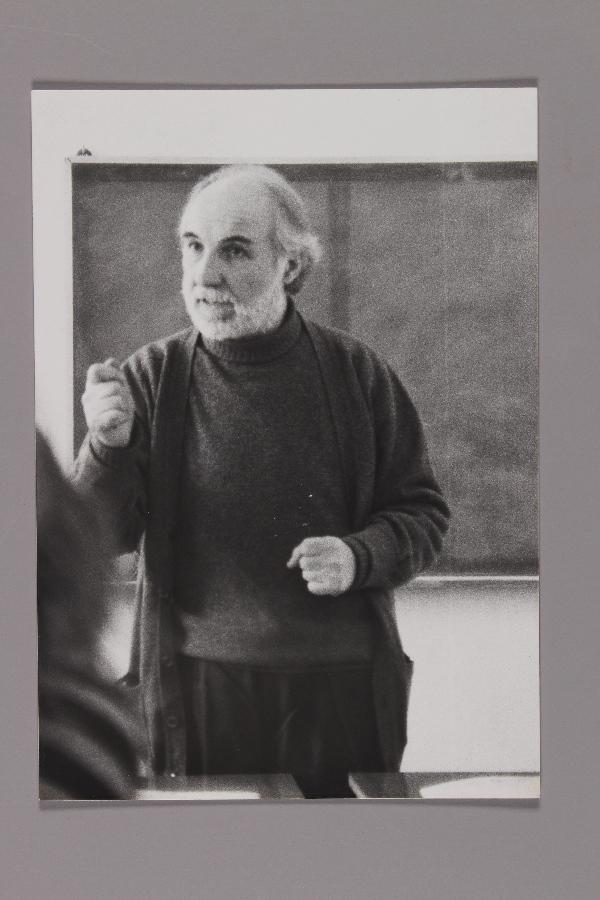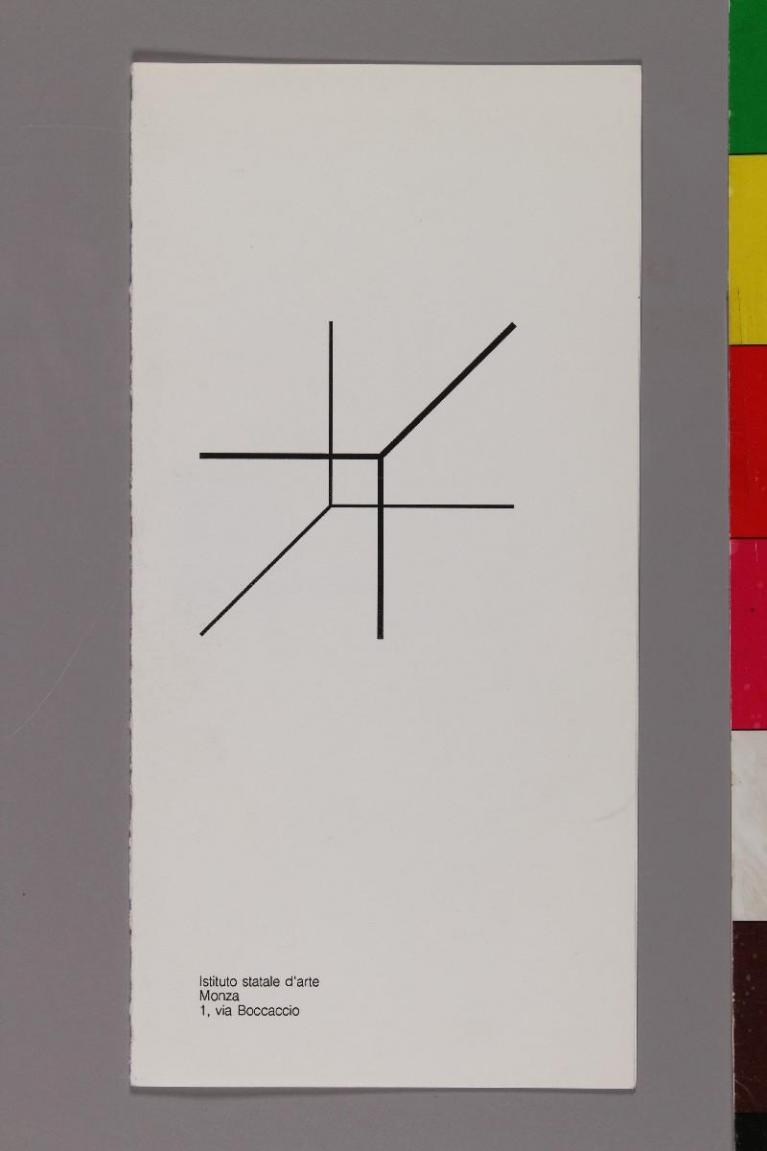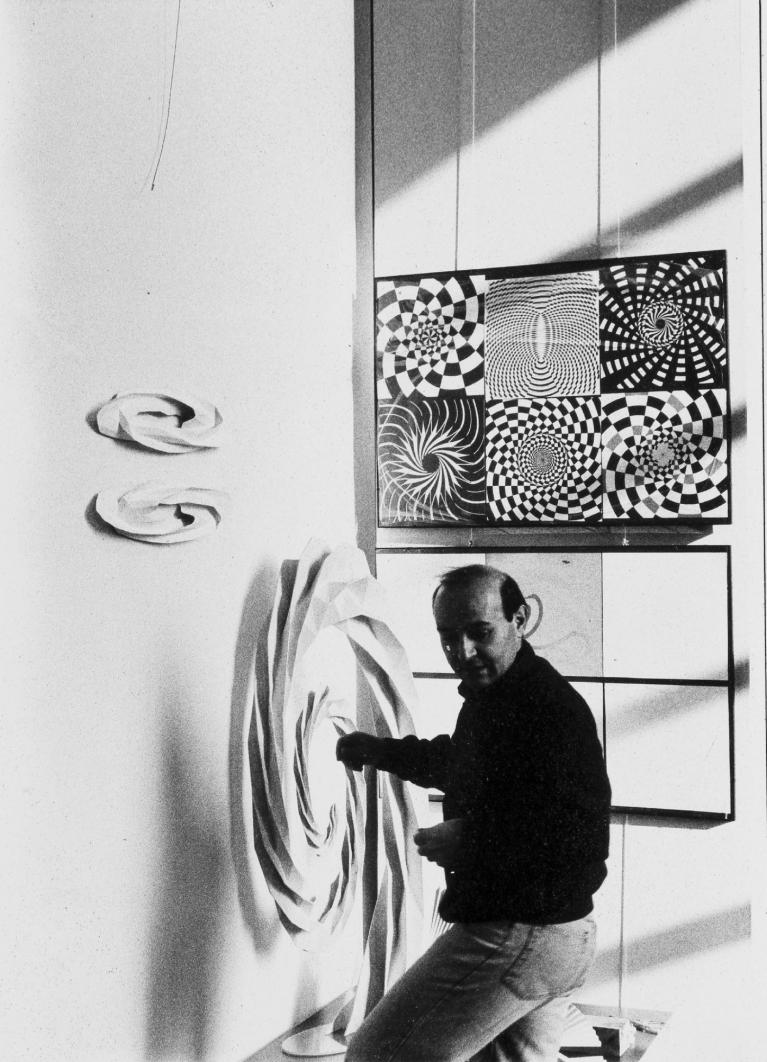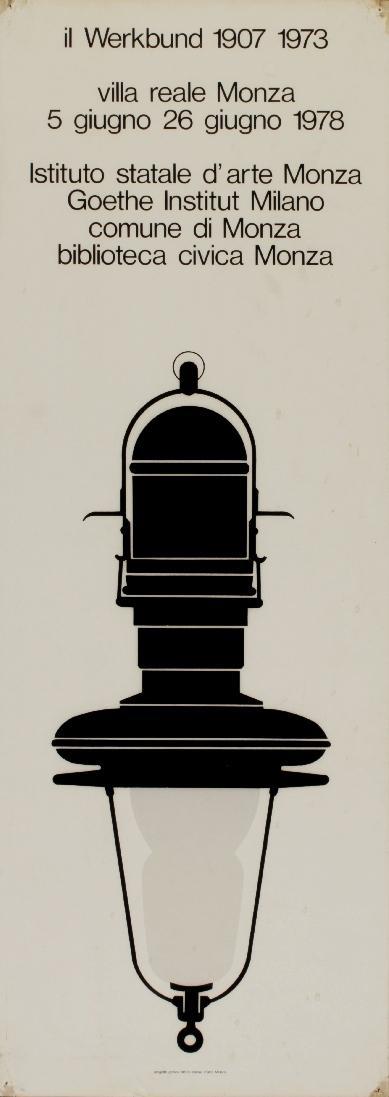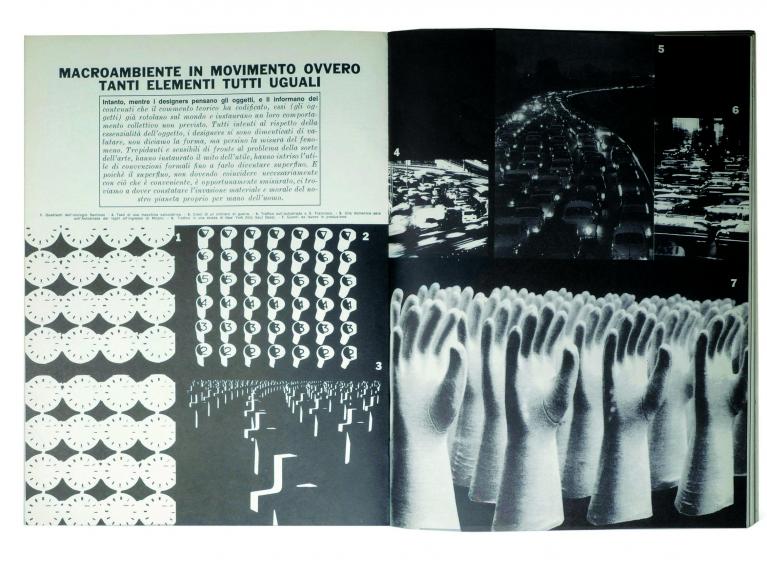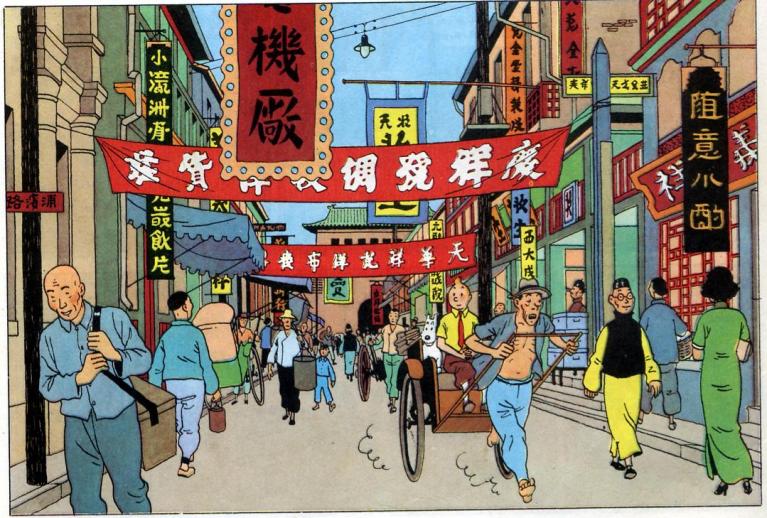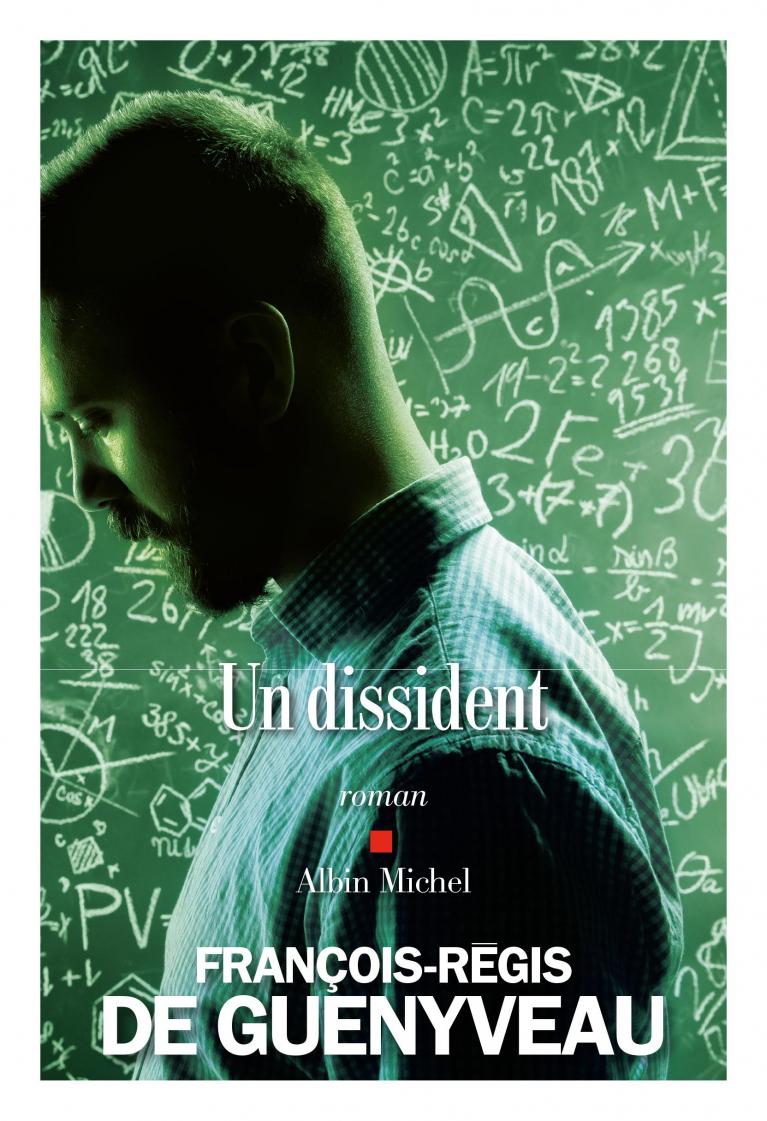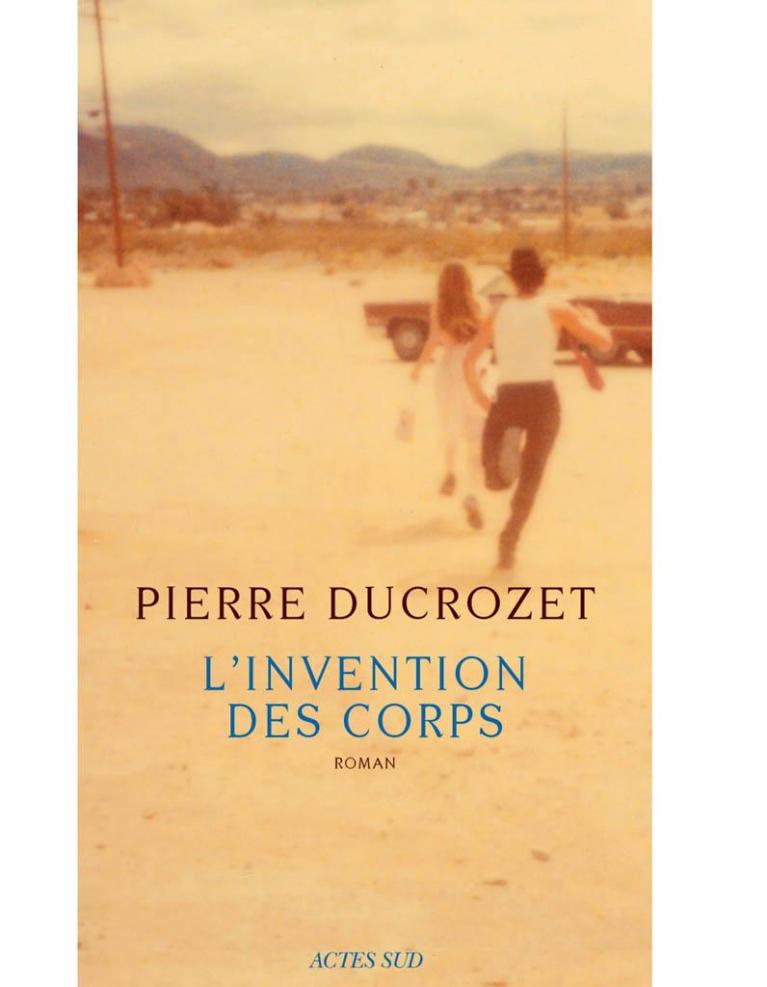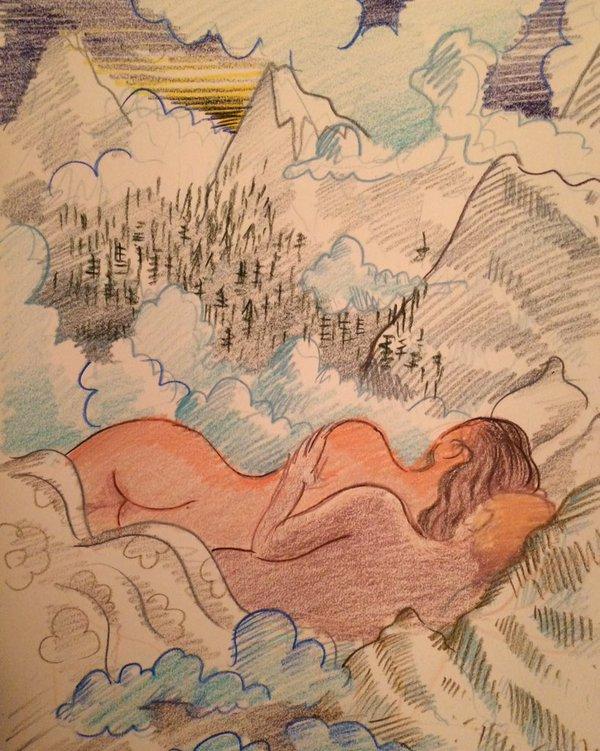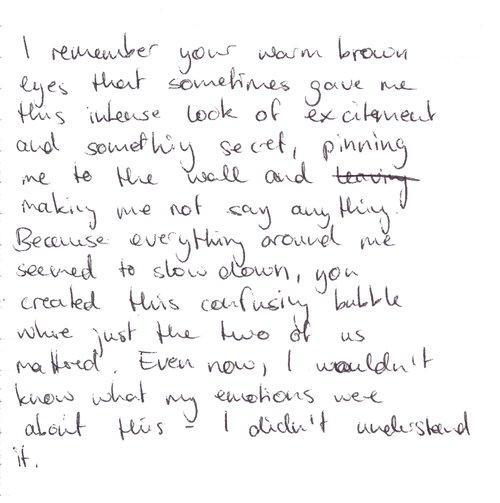Con la pubblicazione di questo volume IV della Storia della sessualità, l’opera pianificata da Michel Foucault nel 1976 e lasciata incompiuta a causa della sua prematura morte, viene dato alle stampe uno degli ultimi tasselli, se non l’ultimo, per comprendere in che direzione stesse andando la teoria del grande pensatore francese nelle ultime fasi della sua produzione.
La lettura della ponderosa opera (426 pagine) divise in tre macrosezioni (La formation d’une expérience nouvelle, Être vierge, Être marié) [La formazione di una nuova esperienza, Essere vergini, Essere sposati] e da 4 annessi, attesa da più di trent’anni dal pubblico specialistico e non, provoca nel lettore sentimenti contrastanti.
Se fosse possibile esprimere in un unico aggettivo questo libro di Foucault, quello che mi verrebbe, di primo acchito, da utilizzare è “inappariscente”.
Il lettore che si aspettasse, infatti, dalle pagine di Les aveux de la chair [Le confessioni della carne] la rivelazione conclusiva, la parola finale, di Foucault sulla sessualità, o sulla sua vita (come ci si sarebbe potuti d’altro canto aspettare, visto che, come nota Frédéric Gros nella sua introduzione, il libro è stato corretto con acribia dall’autore francese fino a un mese prima della morte), rimarrà sicuramente deluso.
Nessuna confessione della carne dell’autore in Le confessioni della carne. Foucault rimane, in questo quarto libro della sua incompiuta Storia della sessualità (mancano all’appello 4 dei libri originariamente programmati da Foucault), sulla scia dei due che lo avevano preceduto, L’uso dei piaceri e La cura di sé, così come egli resta sulla scia delle analisi che fin dagli inizi degli anni ’80 avevano segnato i suoi interessi nei corsi tenuti al Collège de France: quelle sulla costituzione del soggetto nel mondo antico.
Se, infatti, il volume II e III della storia della sessualità erano stati dedicati al modo in cui – nel mondo pagano tardoantico, e in particolare nelle scuole filosofiche – la sessualità era stata ricompresa entro un sistema etico-pratico mirato a costituire un soggetto sovrano, padrone di se stesso, il volume IV è da comprendersi all’insegna della continuità con i precedenti, malgrado lo spostamento del focus al periodo cristiano.
Foucault analizza, infatti, la sessualità dei primi secoli del Cristianesimo (con particolare interesse ai secoli II, III e IV), impegnandosi a sottolineare come essa sia da comprendere, e da ricomprendere, entro le coordinate etiche che già lo stoicismo (e in generale la filosofia degli ultimi secoli dell’antichità pagana) aveva contribuito a delineare, pur sottolineando di volta in volta le differenze specifiche apportate dal Cristianesimo.
Il testo, come detto, è diviso in tre macrosezioni: la prima funziona, tra l’altro, da parte introduttivo-metodologica, ponendosi fin dal titolo la domanda sulle condizioni, e sulla qualità specifica, della nascita dell’esperienza della “carne” propriamente cristiana. Nella seconda e nella terza sezione, invece, vengono analizzate nello specifico due delle esperienze della “carne”, vale a dire del corpo sessuato, che saranno al centro delle elaborazioni teoriche cristiane dei primi secoli: vale a dire la verginità (sezione II) e il matrimonio (sezione III).
Queste tre macrosezioni sono a loro volta ripartite in ulteriori sottocapitoli, che seguono un andamento argomentativo, si potrebbe dire, “decostruttivo”, nel senso di un close reading ermeneutico dei testi antichi che Foucault ritiene particolarmente paradigmatici per descrivere l’esperienza della sessualità nei primi secoli del Cristianesimo.
La prima sezione riprende e articola un tema caro all’ultimo Foucault, quello delle tecnologie del soggetto, quelle “tecniche del Sé” che Foucault, in un famoso seminario del 1982 presso l’Università del Vermont, ha portato alla fama della critica, facendone un strumento-cardine delle analisi in campo storico-culturale che verranno dopo di lui. In particolare, l’oggetto delle analisi foucaultiane è il Pedagogo di Clemente Alessandrino, un libro che incontra l’interesse del pensatore francese in quanto teorizzazione di un “regime” (p. 17), di un insieme prescrittivo di regole mirato a insegnare “l’arte di vivere cristianamente” (p. 12). Questa “arte di vivere”, che traduce nel linguaggio foucaultiano il greco “tekhne perì bion” (p. 11), non è altro che un modo per indicare come il soggetto non sia che il risultato di una serie di tecniche, di “arti”, vale a dire di azioni e di ripetizioni di azioni, di riflessioni e esercizi del pensiero, che lo costituiscono stratificandosi, e non qualcosa che sia fisso, stabilito da una cosiddetta “natura umana” che ne indirizzerebbe la condotta. Questa, per lo meno, è l’idea di soggettività che Foucault ritrova, in questa primissima fase della trattatistica cristiana, come eredità del concetto di soggetto proprio del mondo filosofico tardoantico che era stato analizzato nei precedenti volumi della Storia della sessualità.
Nel testo di Clemente Alessandrino, in particolare, Foucault trova prefigurate due linee direttive che influenzeranno tutta l’etica cristiana, e per questo lo ritiene particolarmente rilevante: da un lato viene affrontato il tema della verginità, e dall’altro quello della concupiscenza.
Questi due nuovi temi, dal canto loro, nell’interpretazione foucaultiana rispecchiano due cambiamenti interni al Cristianesimo stesso, o meglio, due conseguenze legate alla sua strutturazione come Chiesa (Foucault ripete più volte che uno dei punti più importanti della religione cristiana è che essa è stata la prima religione del mondo antico a strutturarsi come Chiesa): l’affermazione della disciplina penitenziale e quella dell’ascesi monastica. Entrambi questi fattori avranno delle conseguenze molto rilevanti nella storia del soggetto occidentale: essi, infatti, da un lato indirizzeranno e segneranno le modalità del rapporto a sé del soggetto, mentre dall’altro andranno nella direzione dell’instaurazione di un legame tra il concetto di male e quello di verità.
Questo punto è da tenere particolarmente in considerazione, in quanto, per Foucault, il tipo di soggetto che si dà entro un preciso contesto storico è da porsi al termine delle pratiche che – instaurate sia tramite l’esercizio individuale che tramite le pressioni verticali degli apparati di sapere e di potere (tra cui rientra anche il dispositivo-religione) – ne costituiscono l’esperienza. In questo senso anche l’esperienza cristiana della “carne” è da comprendersi come un modo di conoscenza e trasformazione di Sé tramite se stessi.
Se, come visto, questa idea che il Sé sia da porre alla fine di una serie di pratiche, di esercizi, è interpretata da Foucault in continuità con le pratiche del Sé del mondo antico-pagano, sono invece il battesimo e la penitenza a creare lo spartiacque decisivo, il proprium del momento cristiano nella creazione di una “nuova esperienza” della sessualità, come la chiama Foucault, ma anche – si potrebbe dire sviluppando l’idea foucaultiana – “dell’esperienza di una nuova soggettività” tout court.
Il battesimo e la penitenza, infatti, sono i due momenti in cui si passa dal paradigma del soggetto pre-cristiano a quello del soggetto cristiano. Per capire questo passaggio, come immagine paradigmatica per il tipo di soggettività “antica” può essere presa la metafora utilizzata da Marco Aurelio, e resa celebre da Pierre Hadot, della “cittadella interiore”: un luogo fortificato, inespugnabile, che tramite una vita di esercizi, di pratiche, di ripetizioni, il soggetto mira a costruire come luogo in cui niente può sottometterlo, in cui nessun evento esterno può espropriarlo da se stesso. Questa soggettività mira ad avere pieno possesso di Sé, a non essere mai “eterodiretta”: né dalle circostanze della vita, né dagli altri. La cittadella interiore è autarchica e fortificata, in essa possono trovare conforto sia l’uomo più potente del mondo, come l’imperatore Marco Aurelio, che uno schiavo come il filosofo Epitteto. Rispetto all’autarchia della cittadella interiore antica il cristianesimo introduce un nuovo tipo di soggettività, che ha come punto di partenza la constatazione di un’insufficienza radicale del soggetto: il battesimo e la penitenza ne sono la riprova. Entrambe queste pratiche, infatti, certificano il fatto che per salvarsi, nel modo di vedere il soggetto introdotto dalla cristianità, non si basta a se stessi: non c’è salvezza senza il battesimo, ossia tramite il lavacro del peccato originale da parte di Dio, che lo concede tramite un atto di grazia e di generosità totalmente libera e sovrana, così come non c’è salvezza tramite la penitenza, che – in particolare nel cristianesimo dei primi secoli – aveva carattere spettacolare, pubblico, ostentativo.
La penitenza doveva essere pubblica, perché il soggetto, in qualche modo, “morisse” al mondo di una morte sociale, ritualizzata, e potesse, tramite il perdono della comunità, continuare a vivere da “trasfigurato” in attesa del giudizio finale. In questo senso, la spettacolare pratica di confessione pubblica dei peccati che è spesso al centro dell’interesse di Foucault, l’exomologesis (a cui è dedicato anche l’annesso 2 del testo), rappresenta la versione simbolica del martirio, della pratica, cioè, che testimoniava dell’esistenza di un valore superiore alla vita di questo mondo tramite il proprio annientamento. Se nel martirio questo annientamento era fisico, nell’exomologesis la morte che il soggetto si dà tramite la patetica confessione di colpevolezza di fronte alla comunità è una morte simbolica.
Senza la confessione, senza l’esposizione, che assumeva pure i caratteri dell’espropriazione, del soggetto ad opera dell’istanza comunitaria, di Dio, o della Chiesa, non c’era salvezza: in questo diventa emblematico, per Foucault, l’episodio di Caino (ripreso nell’annesso 4) nell’interpretazione di Giovanni Crisostomo: la colpa del primo fratricida non sarebbe tanto quella della violenza commessa ai danni di Abele, quanto l’aver taciuto – una volta interrogato – il fatto a Dio. L’assenza di confessione, non l’omicidio, è stato quindi il peccato mortale di Caino. Questa insistenza sulla verbalizzazione ai fini della penitenza, porta anche, indirettamente (Foucault non lo dice esplicitamente, se pure le sue analisi sembrano andare esattamente in questa direzione) alla formulazione di una nuova teoria del soggetto, tutta cristiana: quella che non vede più il soggetto stesso come un insieme, come il risultato di un fascio di azioni, da cui la soggettività scaturirebbe come punto finale, bensì come un qualcosa di dato, segnato fin dall’inizio dal marchio – ad esempio – del peccato originale, e che può (e deve) essere influenzato, corretto, tramite una serie di azioni, e che deve essere portato alla luce tramite un processo di continua verbalizzazione.
![Illustrazione di Alphachanneling.]()
Illustrazione di Alphachanneling.
Vedremo in seguito come quest’idea sarà, da questo punto in poi del libro, la linea direttiva di tutte le sue analisi “archeologiche”. Questo processo di riduzione e di riconduzione degli atti al soggetto troverà i suoi ultimi e più compiuti sviluppi nelle pratiche confessionali, che all’inizio – nell’exomologesis– erano invece per lo più mirate alla rottura, alla destituzione della (vecchia) soggettività.
L’idea di “espropriazione della soggettività” propria del Cristianesimo trova, secondo Foucault, adeguata rappresentazione nel mutamento che le pratiche di direzione di coscienza assumono tra mondo pagano e mondo cristiano. Se nel mondo filosofico antico la direzione di coscienza era una pratica situativa, occasionale, potremmo dire, legata al superamento di un evento traumatico o di una situazione puntuale (ci si affidava, in un momento personale difficile, a un filosofo o a un uomo saggio, che impartiva per un certo periodo di tempo una serie di esercizi fisici e spirituali al fine di oltrepassare il momento critico), nel mondo cristiano – e in particolare nel monachesimo – essa diventa un’istituzione, mirata a “esteriorizzare” il soggetto, che – nella pratica della confessione continua – viene espropriato, e “consegnato” a un altro, che lo deve guidare. Questa guida è indispensabile nel cammino di introspezione e di elevazione che deve fare il cristiano: per questo il monastero, e la vita dei monaci cenobiti, è quella che viene presa come esempio ideale nella letteratura cristiana. Il cenobio diventa quel laboratorio privilegiato in cui è possibile attuare al meglio quelle pratiche di direzione di coscienza che altrove – ad esempio nel caso del monachesimo anacoretico – sono difficilmente regolamentabili e osservabili. Inoltre la direzione di coscienza si struttura – sotto il nome di oboedientia– come vera e propria tecnologia del Sé, atta a “educare” il perfetto cristiano alla mortificazione della propria volontà.
Tutta l’obbedienza monastica si configura come una progressiva abolizione della volontà, che si attuava in passaggi progressivi: volere – in prima battuta – quello che vuole un altro, cessare – poi – di resistere alla volontà altrui e, infine, cessare di volere tout court. Queste tre tappe erano l’obiettivo di una serie di esercizi, di tecnologie del Sé, il cui lato “espropriante” è evidente (soprattutto se le si confronta con quelle tecniche ascetiche proprie del mondo antico – come gli esercizi spirituali degli stoici – che erano mirati alla costituzione di un soggetto autonomo e autarchico), e che possono essere ricondotte a tre ordini di pratiche: l’esercizio di un’obbedienza totale, l’esercizio di un’obbedienza formale (ossia che doveva essere esercitata di per sé, indipendentemente dai contenuti) e l’esercizio di un’obbedienza che è fine a sé.
Il paradosso di questi esercizi ascetici di distruzione della volontà è che essi – in particolare nel IV secolo – si pongono secondo Foucault come la formalizzazione di una tendenza anti-ascetica del Cristianesimo. Essi, infatti, ponendo l’accento sull’espropriazione del Sé e sull’abbandono della volontà tramite l’esercizio di un’obbedienza assoluta, si ponevano come istanze di controllo sulle tendenze più estreme – si potrebbe dire addirittura anarchico-individualistiche – dell’ascetismo individualista degli anacoreti. Questi, con le loro pratiche estreme di macerazione della carne, risultavano essere una pericolosa istanza anti-sistemica, che doveva essere regolamentata, ricondotta entro la struttura della Chiesa: questa, in quanto istituzione che si andava sempre più consolidando, anche nei suoi rapporti con il potere politico, non poteva permettere che si diffondesse l’idea che la salvezza era possibile anche senza la sua mediazione. È in questo contesto che si situa l’analisi foucaultiana del concetto di discretio in Cassiano: questo concetto, che indicava l’unione dello sguardo su di sé e della verbalizzazione di sé che erano necessari per raggiungere la salvezza, da un lato, in generale, era stato concepito come “giusto medio”, ossia come strumento che permettesse al monaco di distinguere tra bene e male, dall’altro come riconoscimento sia del giusto momento che della giusta proporzione in cui dovevano essere messe in atto le pratiche penitenziali.
Queste, infatti, non solo non sono sufficienti, ma potevano addirittura essere controproduttive nel cammino verso la salvezza: esse potevano, infatti, indurre il soggetto a credere che la salvezza fosse ottenibile tramite il solo esercizio ascetico, e non tramite la necessaria mediazione della Chiesa. La pratica della discretio consisteva proprio nell’abbandono della libera volontà, che doveva fare spazio alla direzione di coscienza: una direzione totale, che diventa il simbolo, in questa terra, dell’abbandono a Dio e alla sua Grazia, senza la quale – libera e incondizionata, e che in quanto tale non poteva essere “costretta” ad avverarsi tramite gli esercizi ascetici – la Salvezza non è possibile.
Nella seconda sezione del libro Foucault tratta del tema della verginità nel Cristianesimo, che assume un ruolo centrale in quanto prefigurazione della vita nell’Aldilà. Anch’essa viene descritta nei termini di una “tecnologia” (p. 161), di una tecnologia del Sé, che mirava alla salvezza del corpo tramite un lavoro dell’anima su di Sé (p. 175): questo punto appare estremamente rilevante, se si considera la classica interpretazione del Cristianesimo come religione dualista, che separa corpo e anima, o che svaluta il corpo in funzione dell’anima.
Se, infatti, questo può essere vero per alcuni momenti storici e per alcune posizioni teoriche e dogmatiche entro il Cristianesimo stesso, Foucault ci mostra come il panorama sia estremamente differenziato, e come nei primi secoli il corpo avesse una funzione centrale, e non solo come strumento, ma anche come fine in sé.
La verginità ha un posto centrale, secondo Foucault, nelle trattazioni cristiane dei primi secoli, perché essa diventa il “campo di battaglia” che serve al Cristianesimo per separarsi dal paganesimo, da un lato, (che dal canto suo teneva la verginità in grande considerazione), e dalla gnosi, dall’altro. Per questo la verginità teorizzata dagli scrittori cristiani dei primi secoli è qualcosa che viene da un posizionamento dell’anima nei confronti di Dio, e non da un insieme di regole esteriori (come invece viene imputato alla verginità pagana), ed essa non è legata a un rifiuto del corpo, come invece accadeva in alcune sette gnostiche, ma al tentativo di raggiungere, per il corpo, lo stato di perfezione antecedente alla Caduta già in questa vita. La trattatistica cristiana sulla verginità è – secondo Foucault – un momento centrale nell’evoluzione, o meglio, nella “costituzione” del soggetto cristiano, in cui è possibile, da un lato, vedere ancora le tracce del modo stoico greco-romano di intendere la soggettività, mentre dall’altro appare evidente l’instaurarsi di quella che abbiamo visto essere una “nuova esperienza” della carne. Le tracce (ma anche i segni di un incipiente mutamento) del modello pagano di soggettività sono da ritrovare, secondo Foucault, nelle parti della trattatistica cristiana sulla verginità che descrivono quest’ultima secondo un modello “agonistico”, come lotta (sportiva) e come difesa (militare). Il proprium del modello cristiano di soggettività, invece, è da riscontrarsi nella sempre rimarcata necessità di sottoporsi alla direzione di coscienza, al fine di non cadere in tentazione. Quello che merita di essere sottolineato nell’argomentazione di Foucault, è che la metaforica della lotta, onnipresente nella trattatistica cristiana sul tema della verginità, indica come la cittadella interiore pagana, ormai, nel Cristianesimo sia costantemente sotto assedio: il mondo interiore del cristiano è costantemente sotto minaccia, il peccato originale ha spossessato originariamente il soggetto da se stesso, insinuando l’Avversario nel suo nucleo più intimo. In questo contesto diventa ancora più chiaro il ruolo della direzione di coscienza: se neanche la cittadella interiore della soggettività è più sicura, se essa è costantemente travagliata, minacciata, da un nemico che alberga in essa, oltre che posta sotto assedio dal mondo esterno, è solo da un intervento esterno, dall’arrivo di Dio o dei suoi rappresentanti terreni, che prendono la forma della comunità della Chiesa (non a caso spesso descritta come un esercito), che essa può essere salvata.
La terza sezione del testo è dedicata al matrimonio, che viene analizzato come pratica spesso posta in relazione oppositiva alla verginità nella trattatistica cristiana, che si focalizza sul tema per lo più a partire dal IV secolo. Secondo Foucault questo interesse va contestualizzato con il parallelo rafforzarsi e istituzionalizzarsi dell’ascetismo monastico. Se il monachesimo prendeva progressivamente piede, da un lato, dall’altro esso portava con sé il rischio di allontanare il Cristianesimo dalla gente comune, che avrebbe potuto vedere nelle ascesi e negli ideali monastici qualcosa di irraggiungibile, un modello troppo lontano dalla quotidianità. Si affermò, di conseguenza, la trattatistica sul matrimonio come tentativo di regolamentare quella sfera della vita e della comunità che non poteva essere sottoposta al regime di regole a cui venivano sottoposti i monaci: una sorta di quotidianizzazione dell’ascesi (p. 250), che – nata come pratica di rottura con questo mondo – si ritrova paradossalmente rovesciata in una pratica di gestione della vita nel mondo. la gestione della vita matrimoniale prende, nella trattatistica, soprattutto la forma della gestione della vita sessuale entro il matrimonio, o meglio, il matrimonio viene visto (ad esempio nella grande trattatistica dedicata all’argomento da Giovanni Crisostomo) come un modo per regolamentare la sessualità. È in queste pagine che Foucault si dedica al confronto filosofico più interessante di tutto il libro: quello con il Sant’Agostino del De Genesi ad Litteram e del De bono coniugali. La strategia foucaultiana segue anche in questa interpretazione la linea che abbiamo rilevato nelle sezioni precedenti: quella di individuare continuità e discontinuità tra pratiche mirate alla costituzione del soggetto nel mondo pagano e nel mondo cristiano.
La continuità viene ritrovata da Foucault nel fatto che, anche nella discussione agostiniana del matrimonio, la questione centrale è quella dell’autonomia del soggetto. Il matrimonio servirebbe a far sì che il soggetto cristiano “normale” (quello che non appartiene agli estremi virtuosi della verginità e del monachesimo) non sia preda della libido: e per far sì che esso non lo sia l’istituzione del matrimonio è necessaria in quanto tale, cioè in quanto istituzione. Per questo Agostino utilizza, per descrivere il matrimonio, i termini latini di foedus e pactum, derivati dal lessico giuridico. Questa istituzionalizzazione corrisponde a una regolamentazione delle spinte sessuali, che – in quanto involontarie – non possono essere vietate, e quindi devono essere inserite in una cornice regolamentativa che impedisca che esse prendano il sopravvento sulla volontà del soggetto.
Come si può notare anche in questo punto, resta centrale, come lo era per l’antichità pagana, il tema del soggetto, o meglio, la domanda “come posso appartenermi?”
Vale la pena, avviandoci alle conclusioni, di riportare la discussione foucaultiana del concetto agostiniano di libido. Secondo Agostino, commenta Foucault, il sesso, di per sé, non è da considerare peccato: altrimenti sarebbe stato inspiegabile il fatto che Dio avesse creato la differenza sessuale già nel Paradiso, prima della Caduta. Il sesso (che qui coincide con l’organo sessuale maschile) diventa peccaminoso, e crea vergogna in Adamo ed Eva dopo la cacciata, non in quanto tale, ma a causa del suo movimento involontario.
Per Agostino, infatti, nella condizione paradisiaca, la sessualità era totalmente legata alla volontà: gli organi sessuali seguivano gli ordini dell’intelletto, e per questo il loro movimento, atto di libertà, non costituiva peccato. In seguito al peccato originale, essendosi insediata la concupiscenza nei cuori degli uomini, avendoli essa in qualche modo “spossessati” del proprio Sé, gli organi sessuali diventano “sui juris”: essi seguono un ordinamento proprio, che non risponde alla volontà. Qui sta la vergogna, qui il peccato: nell’aver abdicato una volta per tutte, a causa del peccato, alla completa sovranità su se stessi. Tutto quello che verrà in seguito, inclusa l’istituzione matrimoniale, sarà il tentativo, sempre incompleto, visto che ormai le porte della cittadella interiore sono state aperte – una volta per tutte – all’Avversario, di riottenere la giurisdizione su di Sé.
Foucault non accenna mai, in questi luoghi, al tema dell’inconscio. Eppure appare evidente come quella che Foucault riporta, tramite la teoria della libido di Agostino, sia la narrazione mitica della nascita dell’inconscio (in Occidentale). È come se, alla fine del lavoro di Foucault, che si maschera – come detto in apertura – da commentario non spettacolare ad alcuni testi dimenticati della trattatistica cristiana dei primi secoli, venga avanzata, invece, un’ipotesi assolutamente radicale relativa al processo di civilizzazione: l’idea che le tecnologie del Sé cristiane si dividano da quelle pagane nella misura in cui esse abbiano portato alla creazione del soggetto dell’inconscio, vale a dire di un “io” nascosto, portatore di atti originari, la cui esistenza influenzerà tutta la vita cosciente dell’individuo.
Un soggetto sconosciuto – almeno nella lente interpretativa foucaultiana – al mondo tardo-pagano tanto caro al filosofo francese, mondo che invece vedeva il Sé come un risultato di atti, come una stratificazione di esercizi, e non come una sostanza. Di questo nuovo soggetto, il soggetto-inconscio cristiano, il soggetto del peccato che ci abita e che ci spinge ad agire, era possibile una storia, la storia di una entità estranea posta al centro dell’Io: una storia che necessitava l’esplicitazione, la verbalizzazione, la veri-dizione.
Nel 1976, quando venne pubblicato il primo dei volumi della Storia della sessualità, Foucault aveva annunciato che il progetto avrebbe dovuto prevedere sei volumi. Il quarto e il quinto avrebbero dovuto portare i titoli, rispettivamente, di La femme, la mère et l’hystérique, [La donna, la madre e l’isterica] e di Les pervers [I perversi].
Questi volumi non vedranno mai la luce, ma forse, anche solo dai loro titoli e dal terreno preparato da Les aveux de la chair, traspare quella che sarebbe potuta essere non solo una storia della sessualità, ma pure una controstoria della soggettività e forse, persino, del soggetto dell’inconscio occidentale.