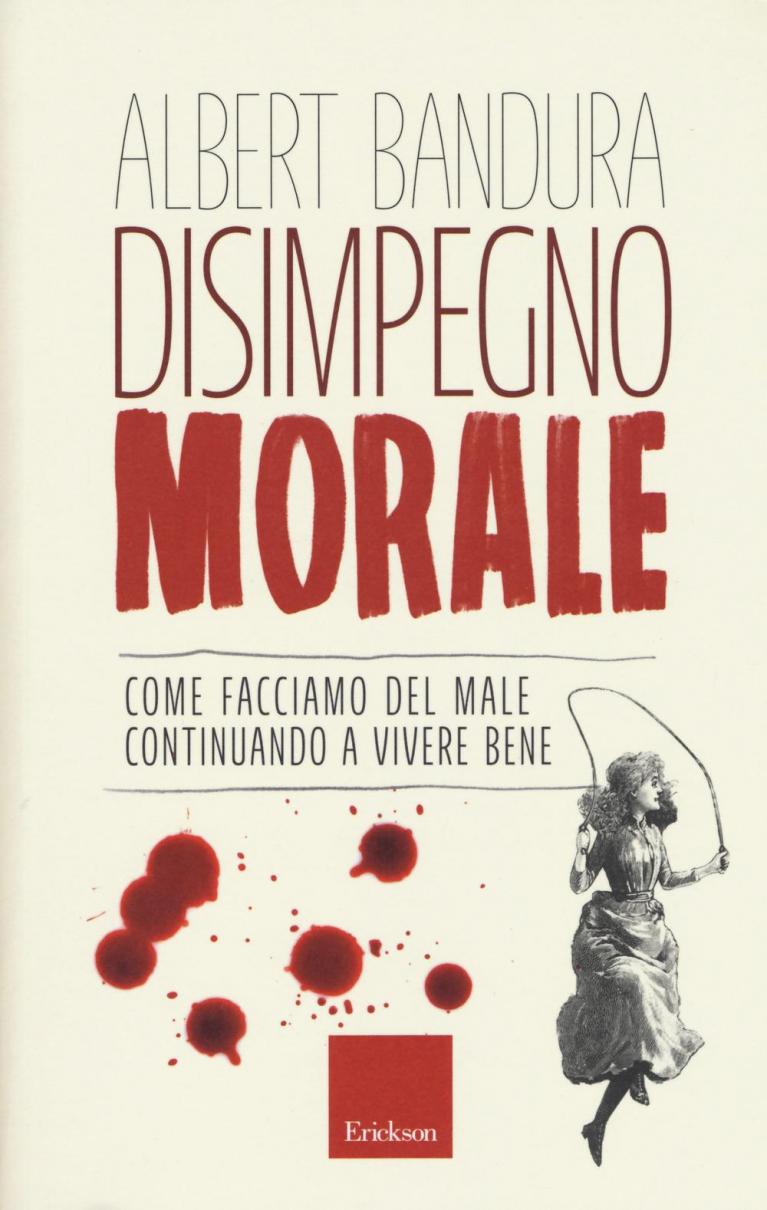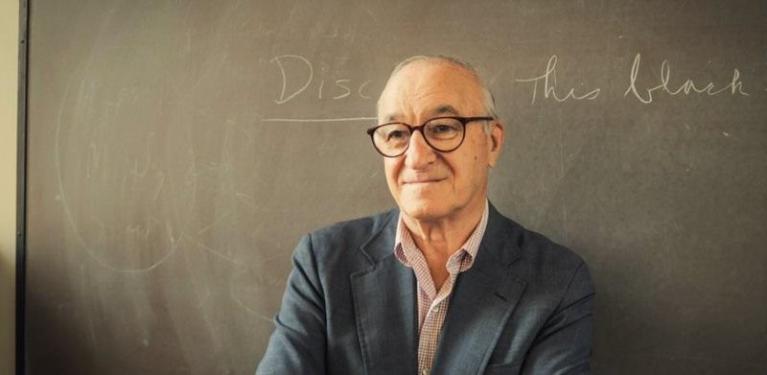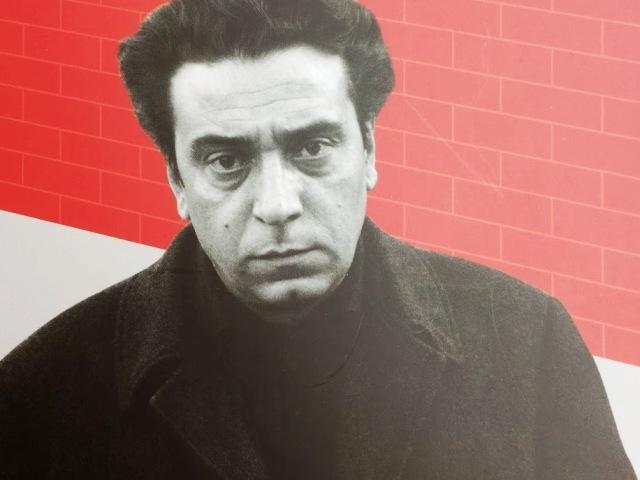Ci sarà qualche ragione se la fama e i lettori di H. P. Lovecraft aumentano di anno in anno, se le edizioni delle sue opere si moltiplicano (in Italia le opere complete sono edite da Mondadori, per la curatela di G. Lippi; e da Newton Compton e Fanucci, fino a edizioni per ragazzi) e non si contano le ristampe di singoli racconti o romanzi, come la recente di Le montagne della follia con la nuova ottima traduzione e curatela di A. Morstabilini per Il saggiatore, ecc. o raccolte “tematiche” in vesti accattivanti e con utili e leggibilissimi apparati, come Cthulhu. I racconti del mito e Il necronomicon che negli ultimi anni sta allestendo ancora Mondadori. Ci sono gli adepti, come in ogni mitologia settoriale che si rispetti, con molti meriti peraltro, che coltivano le loro ritualità, e ci sono gli altri lettori (non dico “normali” perché nessun lettore lo è), che ogni tanto, o a folate, si leggono o rileggono questo o quel volume senza farsi altri problemi al di fuori del piacere, in tutte le sue sfumature, che la lettura può indurre. Anche quella di romanzi dell’orrore può darne, senza essere necessariamente masochisti per provarlo.
Essere invasi dalla paura guardando il cielo è una delle esperienze più antiche dell’uomo; declinata in stupore o sgomento, alternativamente o insieme, a seconda delle circostanze. Si tratta di uno stesso e unico sentimento a cui diamo nomi diversi per evidenziare la sfumatura in un dato momento prevalente, ma la paura prevale sempre, sino a diventare vero e proprio terrore, a volte, da quando la consapevolezza dell’infinita grandezza dell’universo e l’ipotesi non inverosimile di infiniti altri hanno messo radici nelle conoscenze scientifiche e nell’opinione comune. Con tutte le implicazioni, perlopiù confuse, che questo comporta per la percezione di se stessi e della vita, della sua origine e del suo significato, dopo che le religioni hanno cessato per molti di essere delle risposte. Ma anche se “Nessuna forma di vita ha un significato o un principio centrale (…) noi siamo ciò che siamo semplicemente perché lo siamo” (Lettera a R. Kleiner del 13-5-21), al senso pare difficile rinunciare. Uno qualunque. E appena il senso entra in scena, la metafisica da dietro le quinte fa capolino.
“Paura cosmica” e “orrore soprannaturale” ne sono la diretta conseguenza, e prima o poi non poteva che nascerne la corrispondente letteratura: piuttosto tardi che prima però, contrariamente a quanto prevedibile, a meno di non considerare i miti e i libri delle religioni come forma originaria di tale letteratura, chiusa nella gabbia della verità subito dopo essere stata aperta però. Di questa letteratura Howard Phillips Lovecraft è stato il capostipite e resta tuttora il massimo rappresentante. Alla base della sua opera c’è un paradosso, dal momento che essa tratta di temi soprannaturali su base integralmente materialistica, che a ben guardare tale non è: più si fa affidamento sulla ragione e sulle spiegazioni “naturali” e scientifiche infatti, più si resta stupiti, e forse anche sconvolti, non solo da ciò che essa ti mostra e fa intravedere, ma anche dai limiti che essa incontra e che travalicano talmente le sue potenzialità da non poter indurre altro che paura e orrore. Questo mostra come tali confini siano fragili e porosi, e lascia immaginare quanto di innominabile e spaventoso attraverso essi può filtrare in noi e nel mondo che definiamo reale, dove poi giace e fermenta e inquieta, pronto a esplodere o a contagiarlo, che provenga da altri tempi e luoghi e dimensioni, lontanissimi o contigui che siano… Posti di fronte a tali scenari il vago “schema cosmico” che puntella le nostre esistenze traballa, e appunto lì va a innestarsi la letteratura del terrore come la intende Lovecraft (vedi il saggio L’orrore soprannaturale nella letteratura, SugarCo 1978). Il quale in una lettera a Clark Ashton Smith del 20 novembre 1931, scriveva: “Per me, il climax di una storia del terrore è costituito dalla dimostrazione palese di una sconfitta temporanea dello schema cosmico. Per rappresentare ciò, impiego come simboli dei burattini umani: ma il mio interesse non è con loro, è invece nella sensazione della sconfitta di cui dicevo prima, e nel sentimento di liberazione che essa implica. È questo che mi garantisce l’emozione e la catarsi dell’impresa artistica.” Dove a colpire non è la considerazione degli umani come “burattini”, ma il fatto che la sconfitta sia “temporanea”, come del resto è naturale, dal momento che siamo ancora qui a raccontarcela (sulla “catarsi” è meglio sorvolare).

Lo “schema cosmico”, frutto della nostra ignoranza e approssimazione, è del resto la nostra salvezza, come si evince dall’incipit di Il richiamo di Cthulhu: “A mio avviso, il favore più grande che il cielo ci ha reso è l’incapacità della mente umana di mettere in relazione tutto ciò che esso racchiude. Viviamo su un’isola di beata ignoranza posta al centro di neri oceani di infinito, e non era scritto che dovessimo attraversarli”. Per questo ogni volta che qualcosa, che venga dall’esterno o dall’interno, ci porta a voler evadere da questa isola, o ci obbliga ad abbandonarla mettendoci di fronte a ciò che abita questi “neri oceani”, la sensazione che si prova è quella di uno sgomento mostruoso, che travalica i nostri strumenti di comprensione, morale oltre che intellettuale.
Non a caso uno degli aggettivi più usati da Lovecraft, materialista e ateo, era “blasfemo”, con i suoi paggetti “sacrilego”, “empio”, “eretico” ecc., riferito più o meno a tutto (esseri viventi e sognati, reali e mitologici, luoghi, cose, libri, sculture, immagini, voci, odori: a p. 99 di Le montagne della follia, persino una “connessione”, anche se “con i dimenticati eoni solitamente preclusi alla nostra specie”, che beh, allora ci sta pure), tanto che vien da pensare che blasfema, per lui, fosse la realtà in tutte le sue dimensioni, spazio-temporali e “altre”: un’offesa “innominabile” (altro aggettivo del suo pantheon linguistico) a princìpi superiori peraltro inesistenti, e in ultima analisi, anche se non sta bene dirlo, alla sua personale sensibilità, a lui stesso. Anche per questo Lovecraft piace a coloro che si sentono offesi dal mondo (questo, e a maggior ragione gli altri, che, come sosteneva anche Philip K. Dick, sono persino peggio): a ragione Michel Houellebecq sottotitola Contro il mondo, contro la vita il suo notevole libretto sul nostro autore (Bompiani, 2001). Cioè praticamente tutti. Incluso il sottoscritto.
Anche se lui ovviamente avrebbe preso come una volgare insinuazione questa deduzione riduzionista. In un certo senso lo è. Lui era un razionalista a cui erano completamente estranei l’antropocentrismo e i pregiudizi suoi corollari; si dichiarava “indifferentista” (corsivo suo), uno che non commetteva l’errore di interpretare il cosmo e le sue forze come dirette a uno scopo e tantomeno preoccupate della sorte e del benessere o malessere dei suoi abitanti. Non c‘è bene o male: ci sono solo gli effetti di queste forze, che da chi le incrocia vengono avvertiti in modo positivo o negativo. Ma quelli sono solo affari suoi.
In realtà il vero bestemmiatore è lui, ateo integrale, che mette al centro del suo cosmo divinità idiote, che blaterano senza senso, non sanno quello che fanno, si muovono a fatica quando sono sulla terra, si fanno ricacciare in altre dimensioni da qualche formula o se ne stanno relegate negli abissi terrestri o oceanici, o di altri universi, aspettando tranquillamente che si aprano porte dimensionali o che qualcuno li riporti fuori quando si verificano le condizioni, perlopiù astrali, adatte. Nel frattempo li si può immaginare che fanno la calza, o se ne stanno da qualche parte a bollire nella loro rabbia, storditi da non si sa cosa, forse dal loro stesso puzzo disgustosissimo. Il puzzo è una degli indizi più sicuri della loro presenza; ma per Lovecraft ogni odore è disgustoso, peraltro forse perché associato alla materia (al corpo), e in particolare alla materia in putrefazione (l’associazione con il sesso è fin troppo facile e quindi non saremo così banali da istituirla).
Per quanto razionalisti incalliti come il loro autore fossero la maggior parte dei suoi protagonisti e narratori che tentavano vanamente di far quadrare tutto, e nonostante lui stesso abbia accennato qua e là a dare coerenza ai suoi universi e ai loro abitanti, non è questa che dobbiamo cercare: la comprensione dei singoli testi e l’immersione nei loro specifici territori non richiede la decifrazione dei richiami intertestuali e delle ricorrenze di nomi di luoghi e divinità e di tutta la biblioteca dei libri maledetti, che contribuiscono al lavoro della fantasia senza determinarne con precisione i termini e i caratteri, che restano sempre e comunque quelli che ciascun racconto è in grado di creare di per sé, spesso riuscendovi.
Ciononostante molti hanno cercato di ricostruire in qualche modo il pantheon e la biblioteca sparsi nella sua opera, continuandola e integrando le lacune con tutta una proliferazione di testi più o meno fedeli al canone, come certamente facevano i rapsodi con l’epopea omerica.

La ricostruzione più dettagliata degli “antichi” e della loro storia si ha proprio in Le montagne della follia: in esse il narratore trova, nella città perturbante scoperta oltre le altissime montagne prima sconosciute al centro dell’Antartide, molti bassorilievi e fregi che sembrano scrittura (p. 124) che ricoprono le pareti di alcuni degli edifici e che, per quanto antichissima espressione di esseri e di culture “aliene” anche nel vero senso della parola, si possono comunque leggere e in qualche misura interpretare. Sculture, monumenti, forme di scrittura li ritroviamo poi anche in altre opere, come se, per quanto primordiali, originarie e assolutamente “altre” possano essere le entità che le hanno prodotte, tutte, non si sa come, alla scrittura e alle arti non potessero che approdare; e come se, allo stesso modo, le specie successive, senza contatti con esse e quindi senza averne ricevuto l’insegnamento, non potessero che scoprirle di nuovo, e trovare qualche forma, benché probabilmente equivoca, di comprensione. La scrittura vivente della Trilogia dell’area X di VanDermeer (2014, trad. it Cristiana Mennella, Einaudi 2015) sembra ispirata da questi testi, e in particolare dalla scrittura degli abissi (p. 127), come criptocitazione per gli adepti e omaggio se indiretto, anche declinato in modi differenti (ma non tanto).
Alcuni hanno interpretato in senso esoterico i riferimenti a libri e divinità di Lovecraft, nonostante l’esplicita dichiarazione della loro origine giocosa, a cui hanno contribuito amici e corrispondenti: ma se uno vuole credere una cosa, una qualche ragione la trova sempre (vedi in proposito i bei testi di Danilo Arona), a dispetto anche del fatto banalissimo che se qualche dio ha voglia e sa come passare da una dimensione spaziotemporale all’altra, lo può fare senza incantesimi e performance di landart varie (rune, pentagrammi e altre eleganti figure), e una volta passato non si mette al servizio di nessuno e nemmeno gli riserva un trattamento di favore perché gli viene reso un qualche culto per lui superfluo e incomprensibile: si fa i cavoli suoi e amen. Sta di fatto che gli uni (i libri) e le altre (le divinità), qualche nervo scoperto talvolta finiscono per toccarlo e le reazioni dei singoli possono comprendere benissimo la paura l’angoscia. Anche queste, per raggiungerci, non si fanno pregare. Così, circoscriverle, cercare di addomesticarle mediante simulazioni in un recinto protetto, anche se non proprio innocente, come la letteratura, venire a patti e gestirle come il bambino di Al di là del principio di piacere di Freud con il suo rocchetto, non è qualcosa di cui vergognarsi. Ma lo sgomento resta sempre. La serenità anche solo ostentata, comunque, è già ammirevole. Tanto, non dura.
I protagonisti delle storie di Lovecraft, come chiunque davanti alla morte, sono sempre soli. Qualche volta hanno il supporto o la compagnia di un amico, destinato però a perire o a perdere il senno. Di donne quasi non c’è traccia, e quando c’è, duole dirlo, è poco lusinghiera (sorvoliamo poi sul razzismo e le simpatie per il fascismo dell’autore, che hanno trovato difensori e accusatori quasi più che nel caso sacrosanto di Heidegger: diciamo solo che i racconti si possono leggere senza tenerne conto, a meno di aver assoluto bisogno di rassicurazioni psico-sociologiche).
Le comunità dove avvengono i fenomeni misteriosi che danno il via alle vicende sono chiuse, e i contatti con l’esterno sono rari. Quando qualcuno, da fuori, o anche dall’interno del gruppo, ma pur sempre ai suoi margini (come nel capolavoro Il colore venuto dallo spazio), viene a sapere o esperisce direttamente ciò che non va, inquietante e repellente, magari ne è anche sconvolto, ma viene colpito come singolo individuo, senza ripercussioni esterne di qualche conto: fuori prevale l’incredulità, l’ironia, o la volontaria cecità, persino nei rari casi in cui persone al di sopra di ogni sospetto di superstizione, come incalliti positivisti e professori universitari, non possono evitare di constatare l’inspiegabile, orrido e innaturale. Eppure siamo già in un’epoca di automobili, treni, giornali, aerei ecc. L’uso della fotografia come prova è singolarmente assente in quasi tutti i libri (tranne nel bellissimo Colui che sussurrava nelle tenebre). Le forze dell’ordine a volte sono presenti ma, come sempre, raramente incidono, o altrimenti fanno danni; gli studiosi, persone fededegne, o non sono credute, se protagonisti, o preferiscono, in quasi tutti gli altri casi, sorvolare o dimenticare, nonostante a volte ci siano tremendi effetti materiali, morti, distruzioni, cadaveri sfigurati in modo inumano, oggetti dalla geometria inquietante e certo non terrestre…
Dei fatti narrati, si dice in Il caso di Charles Dexter Ward (il cui ritratto, tra parentesi, assomiglia molto a Lovecraft stesso), ma vale per tutti i racconti, esistono quasi sempre “prove pressoché definitive, anche se contrastanti con tutte le leggi naturali conosciute”, che però proprio per questo vengono espunte da ogni considerazione, travisate come tali e, più o meno addomesticate, ridotte al noto, o al semplice, e rassicurante, bizzarro.

Il punto di partenza è sempre la negazione. I narratori e testimoni più significativi (lasciamo perdere il popolino e i diretti interessati) sono sempre scettici ostinati che prima di cedere all’evidenza danno voce a tutte le possibili spiegazioni razionali, per cui tanto maggiore sarà poi la loro credibilità di fronte agli eventi che le smentiranno tutte. Se non si raccapezzano loro, figuriamoci gli altri… Figuriamoci noi lettori.
Loro stessi preferirebbero tacere, dimenticare, anche perché l’impossibilità di cancellare o mettere in sordina il ricordo è la sicura premessa della follia. Quando si decidono a scriverne è per dovere, per rendere testimonianza prima di essere travolti da ciò che hanno scoperto o per impedire che vengano compiuti degli errori fatali che potrebbero spalancare le porte dell’orrore e della distruzione per intere regioni se non per tutto il mondo: quello degli uomini quantomeno, come accade con il progetto di spedizione nell’Antartide cha dà il via a Le montagne della follia o per il progetto di un bacino idrico di L’orrore di Dunwitch.
Il linguaggio è di volta in volta indeterminato e allusivo, e precisissimo nel lessico scientifico e tecnico, da referto di dissezione anatomica che descrive minuziosamente la figura e gli arti dei mostri e la materia di cui sono composti, la struttura e resistenza della pelle (come per gli “antichi” di Le montagne della follia ritrovati nel ghiaccio dell’Antartide) che tuttavia nessuna rappresentazione visiva potrebbe rendere in modo realistico e con altrettanta efficacia di quella verbale (anche presso disegnatori straordinari come Alberto Breccia, figuriamoci gli altri), con la sua esattezza nelle designazioni di suoni e colori (se di questo mondo), della geometria e volumetria degli oggetti e delle architetture.
Lo stesso accade per la geografia, anche del New England e Vermont e Rodhe Island che costituiscono le contee dell’orrore lovecraftiano, dove la topografia reale e quella immaginaria si fondono in una sola, come quella di Yoknapatawpha lo è del mondo di Faulkner. Il dato reale o realistico è duplicato da una più vasta geografia ultra o extra-terrena che con essa comunica attraverso passaggi, angoli, voragini, abissi e tutto un sistema di smagliature che crivellano la nostra precaria realtà.
Si ha spesso un accumulo di dettagli, parte dei quali distorti o esagerati, e comunque incongrui, che vengono descritti, o piuttosto elencati, in modo da rafforzare con la loro concretezza l’effetto “realistico” dell’ambiente o dell’evento in questione e di coloro che vi agiscono, quando invece, come Lovecraft peraltro sa benissimo, ne basterebbero molti di meno. Ma l’esagerazione, l’amplificazione e l’accumulo, la distorsione e l’abnorme, sono una scelta precisa: se tutto è abnorme, diventa tutto normale. Magari un normale “altro” ma pur sempre normale. Se tutto è fuori posto, l’ordine è il fuori posto. Il fuori posto diventa l’ordine di quello specifico spazio; il fuori luogo è l’ordine del luogo descritto, il luogo dove gli eventi si producono, e dove narratori e personaggi sono invischiati, tanto che a volte non riescono a evaderne se non portando con sé lo stigma permanente dell’orrore, che a breve o lungo termine non mancherà di produrre i suoi effetti letali.
Però è proprio questo che contribuisce alla suggestione che i racconti di Lovecraft suscitano. Ci si adagia nella normalità anormale dell’orrore, finché lo si dà per scontato, non si mette più in dubbio la sua esistenza, di modo che poi più forte è il colpo che subiamo quando la rivelazione ultima, o il percorso che ad essa conduce, con tutti i gradini che comporta, si manifesta.
“L’universo mitico di Lovecraft è un universo del linguaggio e attraverso il linguaggio opera un ultimo definitivo ribaltamento del nostro preteso universo ‘razionale’” (G. Lippi). Le descrizioni costituiscono uno dei tratti salienti del suo fascino: che si tratti degli “antichi” o delle città intraviste sulle cime delle montagne o ai loro piedi in Le montagne della follia, vere e proprie “cacofonie corporee pietrificate” (per citare fuori contesto il Thomas Bernhard di Amras), sono insieme vivissime e vaghe: se uno prova a raffigurarsele il risultato è deludente, a volte stravagante ma per nulla inquietante, e anzi, spesso, francamente ridicolo… La concretezza singolarizza e definisce, quindi banalizza; a inquietare è il “senza nome” (espressione che L. usa con frequenza, e a buon diritto); anche quando il dettaglio è nominato, l’insieme ha sempre un che di abnorme, di informe, e rimanda a geometrie non euclidee, ignote e vaghissime, la cui stessa evidenza, a incrociarla, disorienta e stordisce. La descrizione “oggettiva” dei paesaggi e delle cose non è quasi mai disgiunta dall’eco delle emozioni che suscitano. Mentre le cose vengono così dettagliatamente sezionate e nominate, quasi nulla di rilevante avviene “in praesentia”, ma viene raccontato solo attraverso memorie altrui o resoconti riportati di coloro che lo stanno magari vivendo ma non possono certo soffermarvisi pressati come sono dal pericolo che quasi sempre li annienterà, o evocato attraverso premonizioni e avvisaglie, poche e nebulose, o dagli effetti, descritti solo in parte tuttavia, per orrore, pietà e, appunto, “indicibilità”. La descrizione e l’adesione a quanto di reale persiste anche nei frangenti più straordinari, la concretezza della resa anche dei dettagli che non rispondono alle leggi della geometria e della percezione abituali, sono perseguiti con tenacia e rigore proprio perché solo così si può giungere al limite dove la possibilità di dire, sperimentata ogni possibilità, viene meno, e l’incontro con cose, esseri o forme “al di là di ogni descrizione” (Montagne, p. 101), anziché sciogliersi nell’indistinto di formule vuote, produce un effetto più credibile e prorompente. L’insistenza analitica che aveva prodotto un fortissimo “effetto di realtà” (per citare Barthes, che garantisce sempre una patente di nobiltà anche ai discorsi più strampalati), diventa così il necessario preambolo all’irreale, come se il razionale, invece di arginare il suo opposto, dell’incomprensibile costituisse la premessa necessaria, e la materia fosse solo un episodio di ciò che materia non è.

Suoni (toni, cadenze, litanie…) e odori (tutti sul versante del disgustoso e nauseabondo)… tutti i sensi sono sollecitati, ma di più quelli a cui si reagisce istintivamente; quelli che non corrispondono a qualcosa di certo, che non consentono definizioni rassicuranti, fossero pure quelle del riconoscimento di una minaccia e della sua fonte, a cui reagiscono invece sempre e per primi gli animali, non ostacolati dalle sovrastrutture della comprensione, della volontà di sapere. Miraggi che poi, spesso, tali non sono.
Prima o poi, a segnare l’avvicinamento al fulcro della storia, il protagonista o la comunità coinvolta, incoccia in “strani incidenti”, a volte minimi, trascurabili: indizi, premonizioni che acquistano il loro senso solo a posteriori ma che sul momento nessuno capisce, o vuole capire per non essere troppo inquietato e mettere in pericolo le proprie routine, e quindi derubrica immediatamente come cose di poco conto, errori percettivi, momenti di confusione, fumisterie, leggende, sogni. La beata innocenza in cui vive la maggior parte della gente, perché ignora o distoglie volontariamente lo sguardo, abilissima a dimenticare, vera professionista dell’oblio, non la preserva però dall’orrore e dal male che la circonda, o con cui vive gomito a gomito separata solo da un sottile diaframma da cui si tiene istintivamente discosta, ma che, non essendo solido e impermeabile, qualcosa lascia sempre filtrare, finché verrà infranto e allora non sarà più possibile sfuggire. Sprofonderanno tutti nel male, conosceranno l’indicibile senza comprenderlo, nella morte e oltre; ma forse già ne sono abitati, custodito in una ben sigillata cripta interiore che al contempo, provvisoriamente, li protegge.
L’orrore però sembra non avere fondo: persino coloro che ai nostri occhi ne rappresentano il colmo, come gli “antichi”, lo provavano al cospetto di qualcuno o qualcosa che a loro stessi era vietato rappresentare; e così non è difficile ipotizzare che anche costoro ne siano invasi di fronte a qualcos’altro a sua volta irrappresentabile e così via, in un regressum ad infinitum horroris. Senza fondo, senza fine è solo il male. Il resto finisce subito. I suoi confini sono presto circoscritti; la sua vita ha un termine sempre prossimo.
“Per quanto semiparalizzati dal terrore, nei nostri animi si gonfiava nonostante tutto una fiamma ardente di meraviglia e curiosità che, alla fine, l’ebbe vinta”, dice il narratore di Le montagne della follia (p. 160-161) descrivendo indirettamente l’effetto, ma prima ancora la causa che induce il lettore a non interrompere la lettura o la visione delle storie di orrore. Si leggono questi libri come una palestra in cui imparare a gestire la paura, con in più (i tempi lo esigono) il piacere di provarla, di esserne assalito, magari giù giù fin nei precordi, senza essere veramente in pericolo. La paura va verso le domande eterne, le profondità spaziotemporali e le dimensioni diverse dalle nostre, anche contigue (perché no), incombenti e imminenti, quelle contro cui, in fondo, non c’è niente da fare (se un dio vuol fare polpette di te e del tuo mondo, che modo hai di impedirlo? con qualche formuletta magica?), così non affronti quelle che davvero incombono su te e sui tuoi figli e fratelli ma che non puoi, sembra, ma di fatto non vuoi impedire (arginare, risolvere), non con un atto o una serie di atti di buona volontà tua e dei tuoi simili (sempre benvenuti peraltro) ma perché dovresti abbattere radicalmente le vere condizioni che le provocano, che sono concrete ma si presentano come trascendenti, anonime e incomprensibili come le divinità di Lovecraft che si agitano idiote, gorgoglianti suoni insensati, al centro dell’universo, il loro che è anche il tuo. Nondimeno la paura resta, questa e quella, irrisolta sempre al fondo, e irresolubile, nonostante le risposte che giustamente si cercano e che a volte, per questo o quello, sono anche trovate.