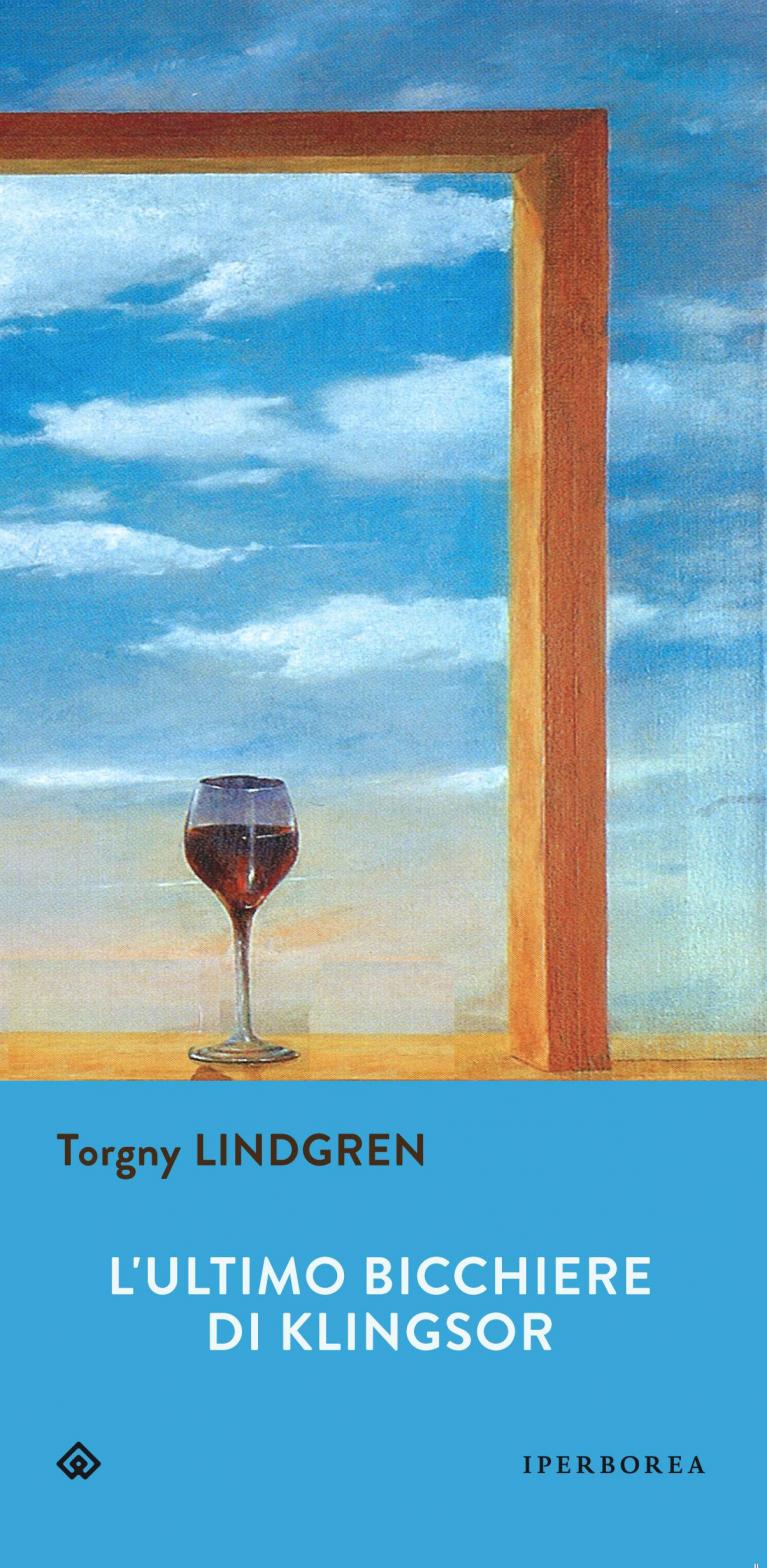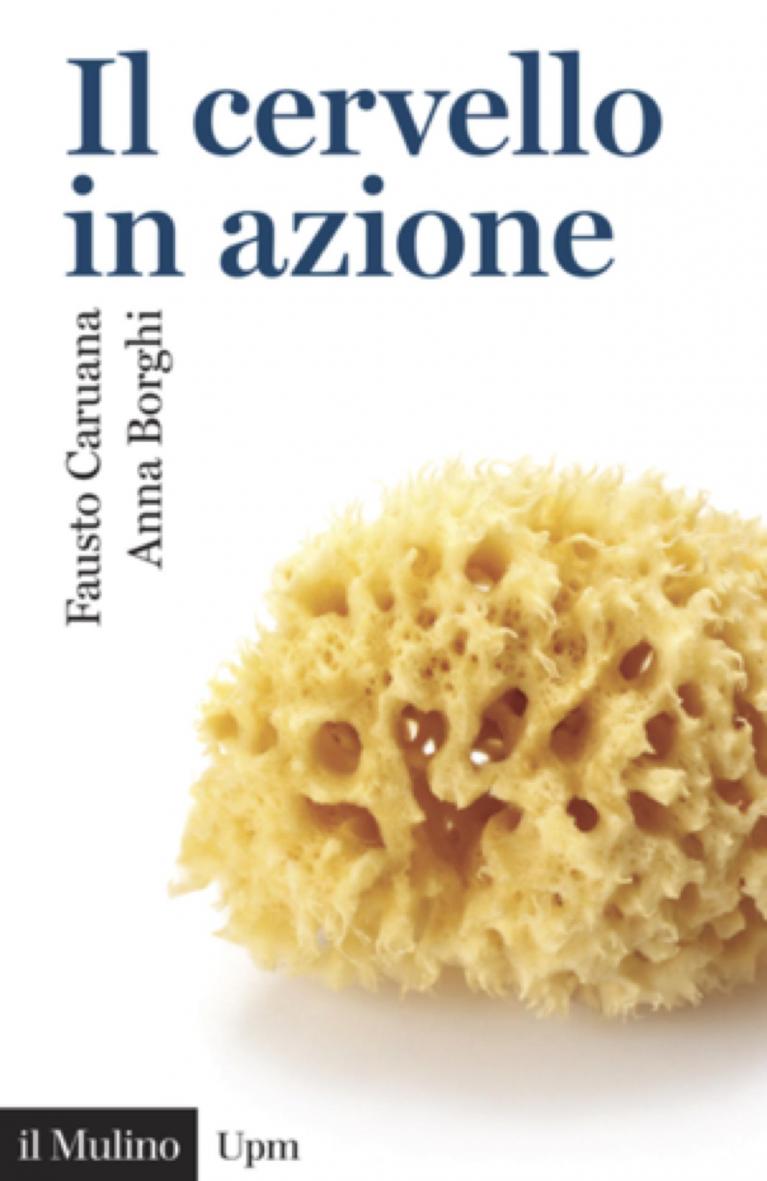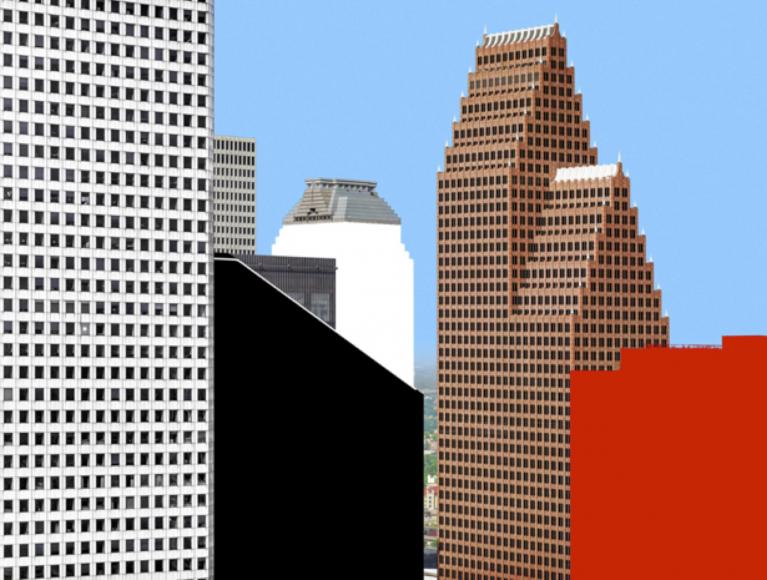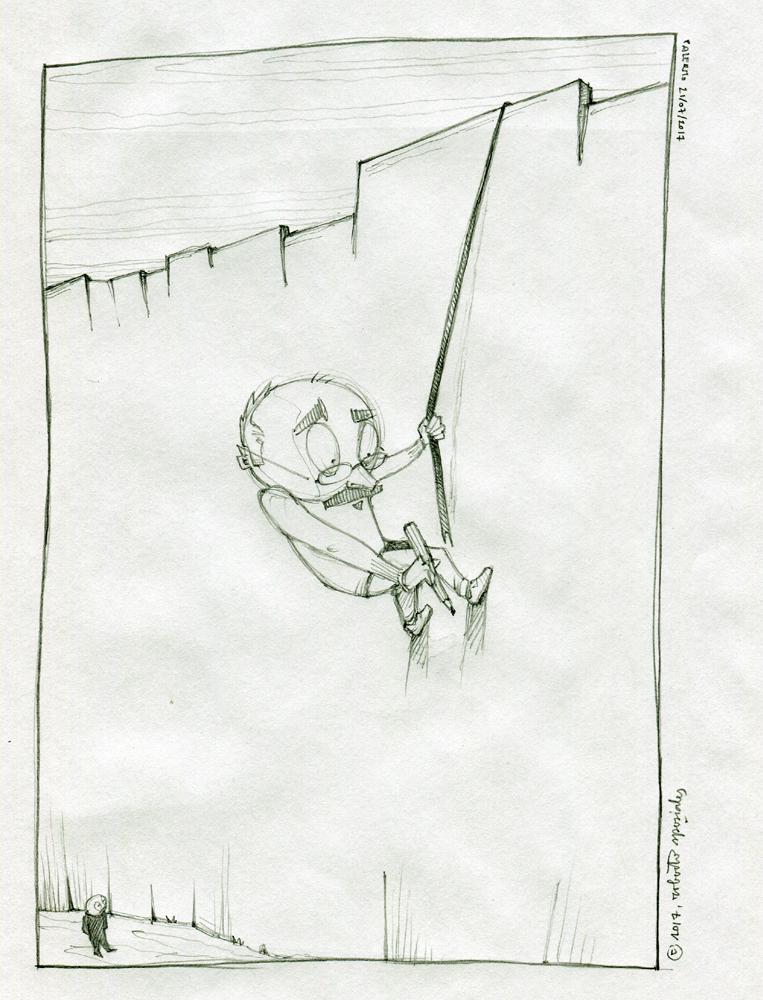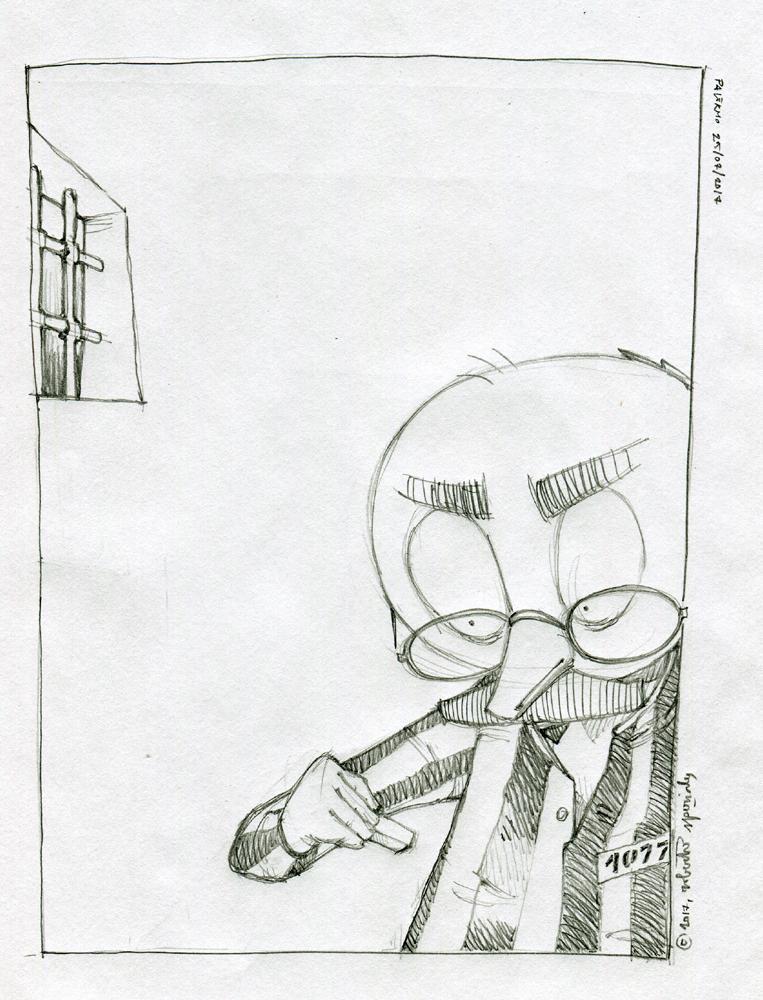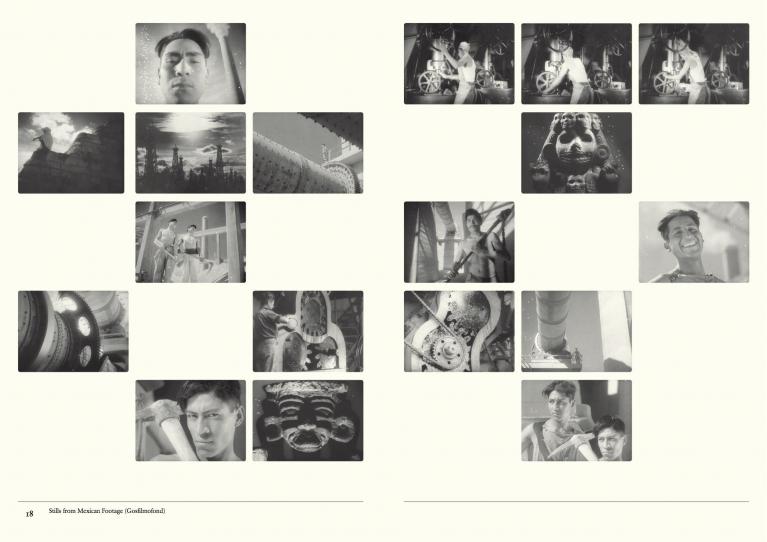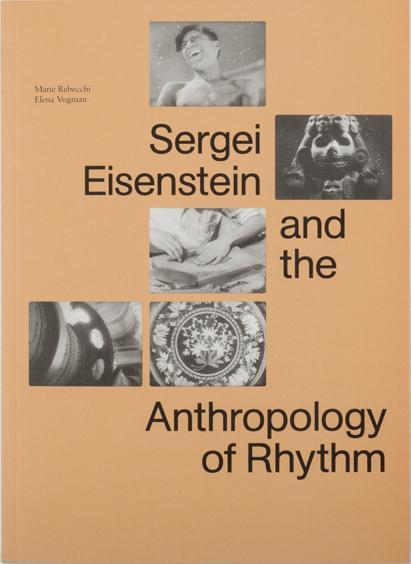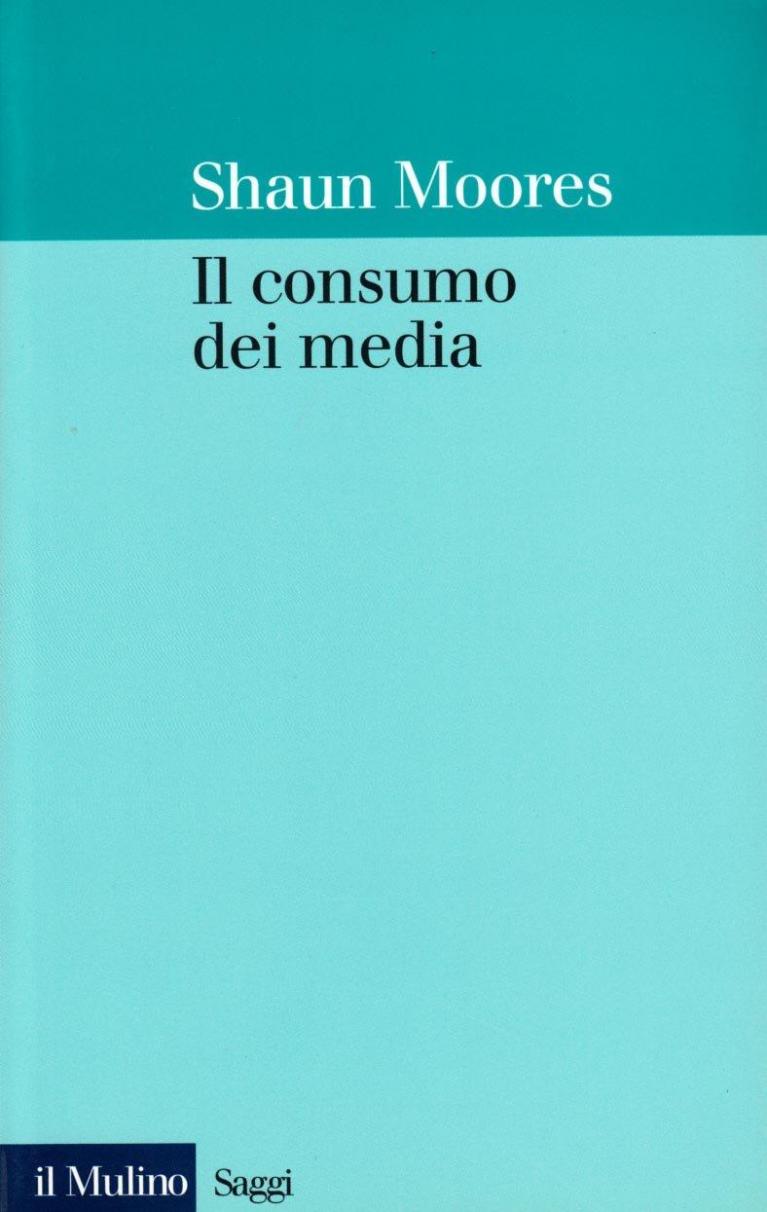La domanda, sottesa alle riflessioni che danno corpo a questo fascicolo di “aut aut”, potrebbe avere la seguente formulazione: “Attraverso il gioco possiamo tentare di disattivare gli effetti negativi dell’attuale agonismo sociale?”. Prima di rispondere con un “sì” o con un “forse sì” bisogna intendersi sulle parole, a cominciare dalla parola “gioco” che è per sua natura sfuggente e difficile da usare.
Nella domanda si dà per scontato che la pratica del gioco sia in grado di stare in una posizione più vantaggiosa rispetto a tutte le pratiche dell’agonismo che ormai caratterizzano le nostre relazioni quotidiane. La premessa è dunque che il gioco segni uno scarto significativo rispetto all’agonismo, non coincida né possa sovrapporsi con esso come invece tendiamo a credere. Ma riusciamo a parlare di gioco, a servirci del gioco, senza considerare che l’agone, l’agón per usare l’antico termine greco, insomma l’agonismo, anche nelle sue varianti più estreme o estremizzate di oggi, è qualcosa che ha a che fare con l’esperienza ludica?
P.A. Rovatti
0. Il titolo in gioco
Ambigua e paradossale, la forma del motto che appare nel titolo è ciò che più lo rende adeguato ad aprire un discorso sull’agonismo. Delle sue tre sezioni [/Chi vince/ /non sa/ /cosa si perde/] quella sensibile è certamente l’ultima, sensibile perché vi si manifestano sia l’ambiguità sia il paradosso.
In quanto all’ambiguità, il /si/ può avervi
[1.] valore intensivo (come in: “l’appassionato non si perde neanche una puntata del programma”)
e
[2.] valore di pronome impersonale (come in: “in questi casi si perde la pazienza”).
La differenza fra i due casi si fa lampante quando si agisce sulla prima sezione, per esempio commutandola alla prima persona singolare. Nel caso [1.], bisogna variare anche la terza sezione: “Se vinco, non so cosa mi perdo”; nel caso [2.], non è necessario: “Se vinco, non so cosa si perde”. Ma è anche vero che, fra [1.] e [2.] poco cambia nel senso generale del motto: “(Chi vince non sa) cosa egli, vincendo, si sia perso / cosa, in generale, vincendo [ci] si perda”.
Il vero punctum del motto sta quindi nel suo carattere di paradosso, che a sua volta è fondato innanzitutto sulla relazione semantica fra “vincere” e “perdere”. È un’opposizione di reciprocità, in cui avviene un’inversione del punto di vista da cui si considera la medesima azione. In questo caso si tratta dell’azione agonistica, che implica la presenza di almeno due soggetti e ha un compimento necessario che può essere descritto in due modi: /A ha vinto su B/ o /B ha perso da A/. Che un soggetto nasca non ha come conseguenza, o implicazione, che un altro soggetto muoia; nella relazione agonistica invece non si vince senza che qualcuno perda. Accade lo stesso alla coppia “acquistare/vendere”. Avrebbe senso una versione commerciale del nostro motto, che dica: “Chi acquista non sa cosa si vende”? Forse no, ma ai lettori di Marcel Mauss potrebbe risultare soddisfacente la versione donativa del motto stesso: “Chi dona non sa cosa riceve”.
Il motto innesca un’attesa: l’attesa che venga confermata l’ovvietà doxastica per la quale uno vince, uno perde. Nei giochi con il danaro, la vincita del primo corrisponde alla perdita dell’altro, tanto è vero che un costrutto come “la perdita del vincitore” avrebbe un ethos perfettamente ossimorico. Ma qui è nascosta una seconda ambiguità. “Perdere” non è solo il reciproco (o inverso) di “vincere”; equivale anche (e questa volta senza correlazione a “vincere”) a “non avere più”, come si osserva nel luogo comune: “Non sai cosa ti perdi”. Scardinando la tautologia “chi vince, vince” e innestandole il luogo comune “non sa cosa si perde”, il motto delude l’attesa che ha suscitato e ribalta la tautologia in un apparente nonsense: “Chi vince, perde (ma non lo sa)”.
Una parola, infine, sulle virgolette. Ho trovato il motto del titolo in una raccolta di aforismi e citazioni legati al mondo del rugby. Non conosco il contesto originario, non saprei come verificarne l’attribuzione, non posso escludere che qualcuno avesse coniato il motto in precedenza e sono consapevole che potrebbe essere altrimenti coniato da chiunque si trovi a commentare una propria sconfitta e cerchi di uscire dalla lizza almeno come “vincitore morale”. Il mio interesse nel motto è nella sua capacità di confondere le acque frettolosamente separate da un’opposizione troppo rigida e piatta fra vincenti e perdenti.
1. Vincenti
Nel corso degli anni ottanta dello scorso secolo, uno slittamento semantico non vistoso ma decisivo ha interessato il participio, aggettivo e sostantivo “vincente”.
Nella sua accezione tradizionale, “vincente” è sinonimo di “vincitore” e di “vittorioso”. È quindi una qualificazione terminativa: giunge alla fine di un’azione. Sembra inoltre in relazione più stretta con la dimensione della “vincita” (“il cavallo vincente”, “la schedina vincente”, il “numero vincente”) piuttosto che con la dimensione della “vittoria”, che si correla più frequentemente al “vincitore”.
Solo in seguito è parsa prevalere un’accezione, al contrario, “incoativa”, quella secondo cui “vincente” nomina la condizione di chi è “abituato a vincere”, ha “il giusto atteggiamento per vincere”, e alla fine dei conti è addirittura “destinato a vincere”. Questa accezione capovolge l’ordine logico e cronologico dell’azione: non è più il vincere che fa il vincente, ma è il vincente che fa il vincere. “Risultare vincente” è la constatazione di un esito agonistico; “essere vincente” è ora una propensione, un’inclinazione, un tratto di carattere (un ethos). Lo stesso, naturalmente, è capitato anche al termine opposto di “perdente”.
Se si concede che questa intuizione semantica abbia un reale fondamento storico e sociolinguistico negli usi lessicali italiani degli anni ottanta, allora si potrebbe metterla in relazione a un’altra osservazione. È stato, quello, anche il periodo in cui alla dimensione politica della “lotta” fra classi si è sostituita la visione delle relazioni sociali come “competizione” fra simili (imprese, gruppi, squadre, individui). Una competizione pervasiva e frattale, diffusa in ogni ambito, ben oltre quelli che Roger Caillois indicava già negli anni cinquanta come settori di incidenza della propensione all’agon, nella vita sociale. La tabella che nel suo trattato Caillois ha posto fra il capitolo 4 (“Degenerazione dei giochi”) e il 5 (“Per una sociologia che parta dai giochi”) prevede:
a. gli sport come “Forme culturali” dell’agonismo “che restano in margine al meccanismo sociale”;
b. la concorrenza in campo commerciale, gli esami e i concorsi come “Forme istituzionali integrate alla vita sociale”;
c. “violenza, volontà di potenza, astuzia, inganno” come forme di “degenerazione” dell’agonismo.
Occorre notare come gli esempi che compaiono nelle prime due caselle (quelle delle “forme marginali” e delle “forme integrate”) sono tutti a vario titolo “istituzioni” e del gioco condividono l’aspetto regolato. Nella terza casella, le “degenerazioni” elencate non sono invece “giochi” bensì “modi di giocare”. Negli stessi termini di Caillois, le prime due sono dalla parte del “ludus” (gioco come matrice formalizzata di regole); la terza dalla parte della “paidia” (gioco come dissipazione di energia), almeno per quello che riguarda violenza e volontà di potenza. Nei termini del saggio di Umberto Eco su Homo ludens di Johan Huizinga, le prime due caselle riguardano il “game” e la terza riguarda il “play”; più in specifico, elenca quattro modi di negare il cosiddetto “fair play”, modi che possono essere praticati anche nelle attività delle prime due caselle. Nello sport avremo il doping, la fallosità “antisportiva” (che danneggia non il giocatore avversario ma la persona del giocatore avversario), la corruzione degli arbitri; nella concorrenza avremo tutte le sue forme sleali, la corruzione degli organismi di controllo, la frode commerciale.
A proposito degli anni ottanta “una sociologia che parta dai giochi” come quella auspicata e fondata da Caillois forse troverebbe da dire che la normale fisiologia della concorrenza, del carrierismo e della valutazione del merito (rispettivamente nei campi agonistici del mercato, della gerarchia aziendale e della docimologia di esami e concorsi) si è come disciolta nell’ubiquità della “performance”. L’aspetto istituzionale della competizione sociale (cioè, il suo game) ha allora cominciato a perdere molto del suo formalismo (avviandosi verso la relativa libertà del play): in campo economico, con la deregulation reaganiana e l’insorgere del neoliberismo; in campo sociale, con la proclamazione thatcheriana dell’inesistenza della società e della centralità dell’individuo; in campo comunicativo, con la nuova informalità del discorso pubblico e con l’esplosione onnipervasiva dei mass media e della pubblicità.
Come per un malinteso para-darwiniano, la “struggle for life” (o una sua parodia) ha occupato ogni ambito. La competizione è diventata la risposta all’egualitarismo della fase precedente e la quantificazione dei meriti – con il conio del neologismo valoriale (o meta-valoriale) “meritocrazia” – ha assunto la funzione di stabilire graduatorie in ogni settore. Audience (tv), incassi (cinema, mostre), copie vendute (editoria periodica e libraria): una società forse più confluente che “affluente” ha scelto l’aritmetica come unica misura possibile del “successo”, con il risultato di moltiplicarlo esponenzialmente, facendo trovare nel successo di un prodotto le ragioni per il suo ulteriore successo.
In Italia lo sport (forma culturale marginale dell’agon) è rappresentato soprattutto dal calcio. Anche grazie alla vittoria italiana ai campionati mondiali del 1982 (e alle sue ricadute sull’immagine e sull’autorappresentazione della nazione), il calcio ha acquisito dagli anni ottanta lo status di campo metaforico privilegiato, anche nel discorso politico, dove locuzioni come “scendere in campo”, “scelta di campo”, “segnare un gol”, “fare melina”, “fare catenaccio”, “finire in fuorigioco”, “prendere in contropiede”, “finire in panchina” (per non parlare dello slogan “Forza Italia!”) sono entrate con naturalezza nella narrazione delle vicende politiche.
In questo quadro la qualifica di “vincente” ha scavalcato (all’indietro) la fase cruciale della performance: da allora non è più la sanzione positiva che dalla performance consegue, ma diventa una forma di “competenza”, che la precede. Per le vite individuali, un carattere, un ascendente zodiacale e, infine, un destino: la “mentalità vincente” (o, al contrario, “perdente”) come qualità principale, nonché definitiva di una personalità. Si può ipotizzare che, nella vita sociale italiana (e non solo italiana), la degenerazione dell’agon sia stata proprio questa.
![]()
2. L’agon in semiotica
Agon deriva dal verbo greco “ágo”, io conduco, guido, e originariamente designava un luogo di riunione. La definizione con cui Caillois presenta la categoria dell’agonè la seguente:
Esiste tutto un gruppo di giochi che presenta le caratteristiche della competizione, vale a dire di un cimento in cui l’uguaglianza delle probabilità di successo viene artificialmente creata affinché gli antagonisti si affrontino in condizioni ideali, tali da attribuire un valore preciso e incontestabile al trionfo del vincitore. Si tratta dunque, ogni volta, di una rivalità che si rapporta a una sola qualità (rapidità, resistenza, forza, memoria, abilità, ingegnosità, ecc.) e si esercita entro limiti ben definiti, senza alcun intervento esterno, in modo che il vincitore appaia il migliore in una determinata categoria di imprese.
È una visione del tutto ideale, in cui l’agon
[…] lascia al campione le sue sole risorse, lo spinge a trarne il miglior partito possibile, lo obbliga infine a servirsene lealmente e entro i limiti stabiliti che, uguali per tutti, hanno in compenso la funzione di rendere indiscutibile la superiorità del vincitore. L’agon si presenta come la forma pura del merito personale e serve a manifestarlo.
Abbiamo già visto che prevaricazione, violenza, astuzia e inganno sono considerate da Caillois come forme degenerative dell’agon e che dunque, per lui, “play” e “fair play” coincidono necessariamente. Questa necessità deriva dall’osservazione (nient’affatto trascurabile) per cui le “condizioni ideali” fornite dalle regole del game e il perfetto rispetto del fair play trovano un corrispettivo (per quanto artificiosamente creato, nell’ambito separato di un gioco) nella loro “funzione di rendere indiscutibile la superiorità del vincitore”. Si è liberi di entrare in un gioco, ma occorre accettarne l’uguaglianza delle regole, per tutti, in modo che l’esito finale sia considerato pienamente valido dal vincitore come dallo sconfitto (come anche da giudici e osservatori).
Portata all’estremo, questa concezione dell’agonismo arriva a far sbiadire la figura dell’avversario, come avviene nell’esposizione della propria filosofia tennistica da parte di Gerhardt Schtitt, il personaggio dell’istruttore capo nell’accademia di tennis di Infinite Jest:
Il vero avversario, la frontiera che include, è il giocatore stesso. C’è sempre e solo l’io là fuori, sul campo, da incontrare, combattere, costringere a venire a patti. Il ragazzo dall’altro lato della rete: lui non è il nemico; è più il partner della danza. Lui è il pretesto o l’occasione per incontrare l’io. E tu sei la sua occasione. Le infinite radici della bellezza del tennis sono autocompetitive. Si compete con i propri limiti per trascendere l’io in immaginazione ed esecuzione. Scompari dentro al gioco: fai breccia nei tuoi limiti: trascendi: migliori: vinci.
Anche per Caillois l’agon è “una rivendicazione della responsabilità personale”, in cui il giocatore “conta solo su sé stesso”. La funzione dell’avversario resta certo necessaria all’agonismo; ma in questo modo di porre la questione il vero obiettivo del gioco è il superamento dei propri limiti, superamento di cui la prevalenza sull’avversario è semplicemente la sanzione.
È qui che la differenza fra “essere vincenti” e “risultare vincenti” produce le maggiori conseguenze e dove appare più chiara la differenza fra la vincita e la vittoria. Se uno dei verbi correlati all’agonismo è “misurarsi”, ritroviamo un’ambiguità simile a quella discussa a proposito del titolo: prendere la “misura” fra sé e un altro implica misurare sé stessi e il verbo esprime nel contempo entrambe le operazioni.
Per la semiotica, l’agon traduce e, in qualche misura, dà sostanza figurativa alla struttura polemica della comunicazione e della stessa significazione. “Il senso si dà nel dissenso”, scrive Gianfranco Marrone e il principio si può applicare alla natura oppositiva e differenziale delle relazioni semantiche più profonde come al confronto fra soggetto e antisoggetto sia all’interno delle strutture narrative sia nella comunicazione.
Ma l’analisi semiotica della dimensione polemica si è trovata costretta ad affiancarla e integrarla (più che opporla) a una dimensione contrattuale. “È indispensabile”, dice Marrone,
che gli stessi contendenti abbiano qualcosa in comune, un codice per capirsi, un sistema di valori condiviso mediante cui dare agli stessi gesti gli stessi valori, alle stesse parole gli stessi significati. Per litigare, occorre prima essere d’accordo sul senso stesso del litigio, sui significati specifici di ciò che ci si rimprovera vicendevolmente. Se ogni contratto presuppone, ovviamente, un conflitto (ci si mette d’accordo per non parlarne più), vale anche il contrario: ogni conflitto presuppone un contratto (si deve essere consapevoli della comune posta in gioco della lotta). Anzi, relazioni polemiche e contrattuali sfumano gradualmente e reciprocamente le une nelle altre.
Qualcosa di analogo càpita, in particolare, nell’universo semiotico dei giochi, dove
[…] gli avversari sono in permanente cooperazione per stabilire il dialogo ludico. Cooperazione sulle regole e sul desiderio condiviso di giocare, cooperazione all’interno del processo speculare di emulazione.
Non si tratta qui di sostituire i giochi competitivi con quelli cooperativi, secondo utopie pedagogiche che non arrivano a distinguere la competizione dalla sopraffazione. Si tratta piuttosto (e all’opposto) di riconoscere gli elementi contrattuali dei rapporti polemici, e quelli polemici dei rapporti contrattuali, come in effetti la semiotica ha saputo da tempo. Questo permette di considerare come l’agonismo possa fuoriuscire dal modello cailloisiano dei giochi e sfociare in una dinamica di dissidio, o di conflitto aperto, in cui la relazione competitiva non trova una cornice collaborativa che contemporaneamente la contenga e la definisca.
Nella storia recente della politica italiana, per esempio, i dispositivi di delegittimazione dell’avversario, la manipolazione delle normative che regolano le interazioni (dai sistemi elettorali ai regolamenti parlamentari), i fallimenti (totali o parziali) di tutti i tentativi di riforma largamente condivisa della seconda parte della Costituzione sono stati i sintomi ricorrenti del rifiuto di vedere una dimensione contrattuale all’interno della relazione polemica; la conseguenza è stato il sabotaggio delle dinamiche di “gioco”. Il sospetto è che il dibattito a proposito del “game” (le “regole del gioco”) abbia oscurato il tema del “play” (la degenerazione dei modi di giocare), dove tutti gli elementi già censiti da Caillois nella sua tabella (violenza, volontà di potenza, inganno e astuzia) hanno finito per forzare le forme istituzionali regolamentate.
3. La posta in gioco
A parte il fatto stesso di essersi occupato del tema, per certi versi, per primo, il principale contributo di Johan Huizinga a ogni teoria del gioco è stato quello di mostrare come il gioco non intervenga a posteriori, né cronologicamente né logicamente, rispetto a istituzioni umane come la giustizia, la poesia, il teatro, la religione. È per questo che quando diciamo che sia nella comunicazione sia nel gioco l’aspetto polemico-competitivo e l’aspetto contrattuale-collaborativo si presuppongono reciprocamente non possiamo dare per scontato che sia il gioco a funzionare secondo il modello comunicativo e non, al contrario, la comunicazione che sia stata modellata dal gioco. Ma sarebbe anche vano volerlo stabilire.
Qualcosa si potrebbe pensare anche a proposito della struttura narrativa di base in cui, secondo Algirdas J. Greimas, un soggetto vuole o non vuole, può o non può, deve o non deve, sa o non sa congiungersi o disgiungersi da un oggetto di valore. Nella teoria dei giochi il soggetto è il giocatore e l’oggetto di valore è, o dovrebbe essere, la posta in gioco. Dal gioco del “fort-da” descritto da Sigmund Freud alla dottrina dell’oggetto transizionale di Donald W. Winnicott, la psicoanalisi del gioco affonda le sue radici proprio nella creazione di uno spazio interposto, un’“area intermedia fra le cose percepite e quelle concepite”: nella prima infanzia è l’area in cui il soggetto sperimenta il dominio sulla sparizione e riapparizione di un oggetto; è la stessa area in cui si sviluppa il linguaggio e, sempre per Winnicott, quel che chiamiamo “creatività”. Ma è proprio così scontato che la posta in gioco sia l’oggetto di valore, nella semiotica del gioco? Innanzitutto va distinto lo scopo interno al gioco dalla sua posta. Il caso è facile quando il gioco mette in palio un oggetto di valore. Nel poker, lo scopo del gioco è formare una combinazione vincente (vincere o, in alternativa, convincere gli altri giocatori all’abbandono); la posta del gioco è il piatto da aggiudicarsi, la vincita conseguente alla vittoria. In altri casi la distinzione è più problematica.
I giochi competitivi si dovrebbero distinguere da quelli collaborativi perché i primi hanno un oggetto di valore comune e conteso fra i soggetti, mentre nei secondi l’oggetto di valore è comune ma non conteso. Nella risoluzione collettiva di un puzzle a tessere (più correttamente, un jig-saw puzzle) lo scopo del gioco è il completamento, ed è comune a tutti i giocatori, che vincono o perdono tutti assieme. Questo carattere evidentemente collaborativo del gioco non esclude che segmenti di agonismo possano determinarsi in certe fasi di gioco e localmente (per esempio, la collocazione particolarmente ostica di una tessera su cui si possono sfidare due o più giocatori).
Non bisogna però sottovalutare neppure i possibili aspetti collaborativi nei giochi competitivi. L’esempio che serve a d’Afflon per illustrare questo punto riguarda, ancora una volta, il tennis. Anche qui lo scopo interno al gioco sembra chiaro: molto in sintesi, evitare che la palla tocchi due volte la propria metà del campo e fare in modo che ciò succeda invece nel campo dell’avversario. La posta in gioco sarà la vittoria in sé, il passaggio del turno o la vincita finale di un trofeo (nonché l’avanzamento nella graduatoria, per i giocatori che si dicono “classificati”). L’osservazione diretta del gioco ci dice però che questo non è affatto soddisfacente se non si instaura una tensione ludica, quello stato di “sospensione” e di incertezza di cui già aveva parlato Caillois. D’Afflon va oltre e afferma che la tensione ludica del tennis è volta non tanto a battere l’avversario quanto
[…] a offrirsi reciprocamente la possibilità di affrontare e padroneggiare le situazioni più difficili e di mantenere questa sospensione. Se si desidera battere il proprio avversario, è per meritare di continuare a giocare contro un avversario ancora più ostico.
Infatti, per il pubblico come per i giocatori, una partita è interessante solo se nessuno dei due prevale troppo agevolmente sull’altro: è questa la “sospensione” capace di creare la tensione ludica che interessa d’Afflon.
“Tensione” è un termine che consente di tradurre in un linguaggio semiotico appena più formale quel (vago ma onnipresente) concetto di “oscillazione” che si incontra sempre parlando di giochi. Oscillazione fra regole e libertà, fra prevalenza dell’uno e dell’altro avversario, fra attacco e difesa, fra incertezza e scioglimento. Come un meccanismo funziona solo se ha “gioco” (se i due elementi che interagiscono non sono né troppo laschi né troppo stretti), così una partita di tennis risulta soddisfacente sia per il pubblico sia per chi la gioca se lo squilibrio finale tra vincente e perdente si determina solo al termine di una fase di equilibrio la più lunga possibile. Lo scopo reale del tennista, dunque, non è il risultare vincente in sé ma aver mantenuto la propria “sospensione” più dell’avversario, malgrado le sollecitazioni a cui si è stati sottoposti dai suoi colpi. A “fare la partita” non è una successione di punti secchi (aces, colpi vincenti), ma la ricorrenza di stati di tensione che punteggia lo scambio. Ogni singolo colpo di A svolge due funzioni: chiude l’azione dell’avversario B (è dunque terminativo; risolve il dubbio: A riuscirà / non riuscirà a colpire la palla?) e contemporaneamente ne apre una nuova (è doppiamente incoativo: il tiro di A sarà / non sarà valido? B riuscirà / non riuscirà a rispondere?).
Riformulato così lo scopo del gioco, si capisce come mai l’ideale del tennis è l’incontro fra giocatori di pari abilità: come segnalato da d’Afflon, una parte importante è giocata dall’“emulazione”. Nel caso in cui si incontrino invece due giocatori di livello impari, il fair play tennistico impone al più forte di non attenuare il proprio impegno ma di onorare il gioco comportandosi come se stesse affrontando un pari grado.
Del resto, come negli scacchi, anche nel tennis i grandi giocatori hanno la qualifica di “Maestri”: giocare contro di loro dà infatti la possibilità di imparare, nell’essere sconfitti. Ecco dunque la posta in gioco alternativa, quello che si perde vincendo e che si vince perdendo. Il vincitore guadagna il prestigio, l’applauso del pubblico, il trofeo: in cambio, dice d’Afflon, offre al perdente un “dono epistemico”, la consapevolezza dei suoi punti deboli, la via per migliorare. La “maestria” è sì una dote individuale ma implica anche una relazione. È anche per questo che ci si diverte di più a giocare contro un avversario più forte di noi, a dispetto della probabilità ovviamente superiore di uscire sconfitti dal match.
In conclusione, lo scopo del tennis è quello di battere l’avversario, o più sottilmente, quello di provare a batterlo? Provare significa “provarsi”, misurarsi, trasformando l’eventuale sconfitta in un’occasione per acquisire maggiore maestria.
4. Competizione e conflitto
D’Afflon finisce per riformulare la famosa quadripartizione di Caillois, trovando che il parametro che distingue agon, alea, mimicry e ilinx (competizione, sfida al caso, mascheramento e vertigine) è costituito da ciò che viene di volta in volta messo in gioco.
Nell’ilinx, è il rapporto con la propriocezione, con la percezione del proprio corpo.
Nella mimicry, si gioca con la propria identità personale.
Nell’alea, si gioca con le potenze metafisiche (gli dèi, la sorte).
Nell’agon, si mettono in gioco le relazioni sociali: competizione e collaborazione, con i loro intrecci e le loro possibili combinazioni, rientrano entrambe nella categoria, e alla pari.
È così possibile distinguere il gioco, anche agonistico, dal conflitto. Nel conflitto si desidera battere quell’avversario particolare; nel gioco, la vera posta è l’agio con cui lo si gioca, la maestria conquistata, la possibilità cioè di esercitare il massimo della propria libertà, l’oscillazione più decisa all’interno dei vincoli stabiliti dalle regole. Il conflitto ha invece come oggetto di valore l’inermità dell’avversario e lì non è davvero importante che l’avversario riconosca formalmente la superiorità del vincitore, che lo ha schiacciato e annullato. Nei codici bellici, la resa e l’onore delle armi sono elementi rituali, che simbolizzano l’ammissione: lo sconfitto si dichiara inferiore al vincitore, il vincitore ammette che lo sconfitto si è battuto. Tale passaggio simbolico è l’elemento che permette di ritornare alla dimensione contrattuale, dopo la fase prevalentemente polemica. Quando questo rituale non viene celebrato, il conflitto non ha più nulla a che vedere con agonismo e gioco poiché mira al puro e semplice annientamento dell’antisoggetto. Di conseguenza il conflitto non ha alcun bisogno di rispettare il fair play e di evitare le degenerazioni elencate da Caillois (violenza, volontà di potenza, astuzia, inganno).